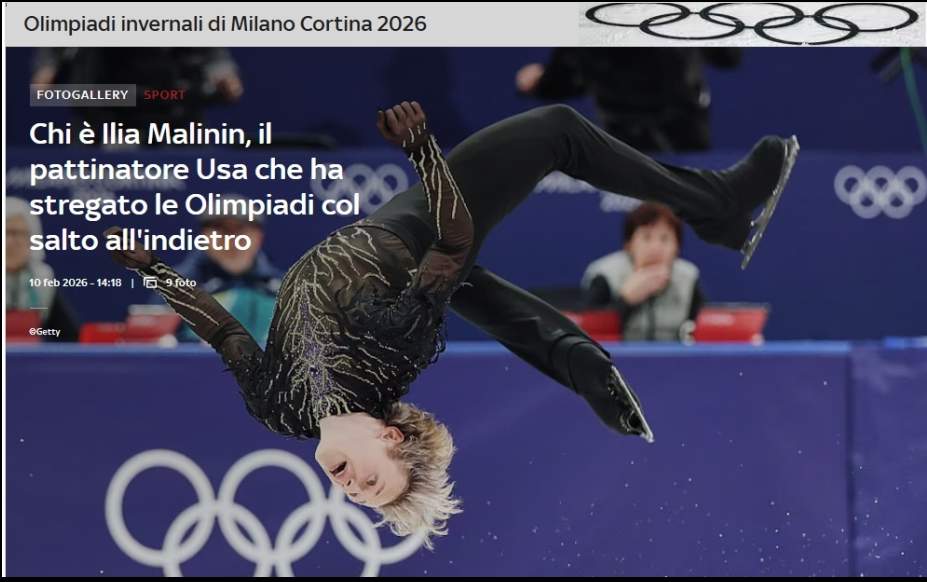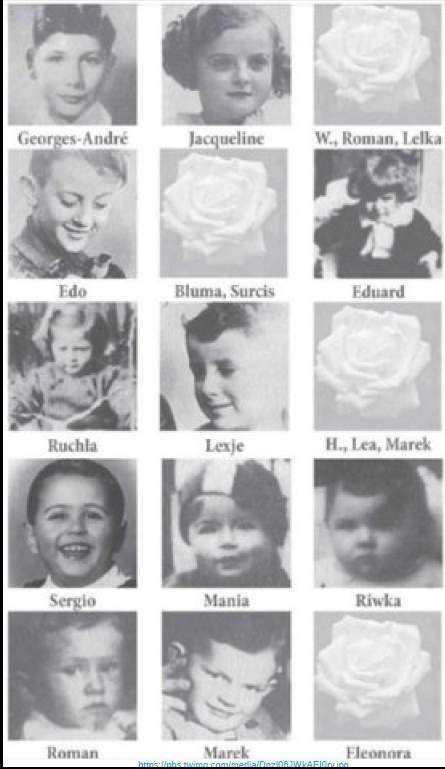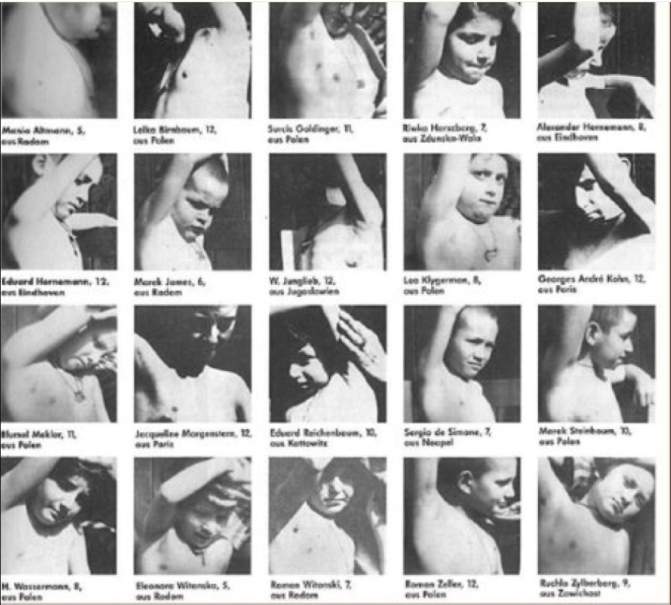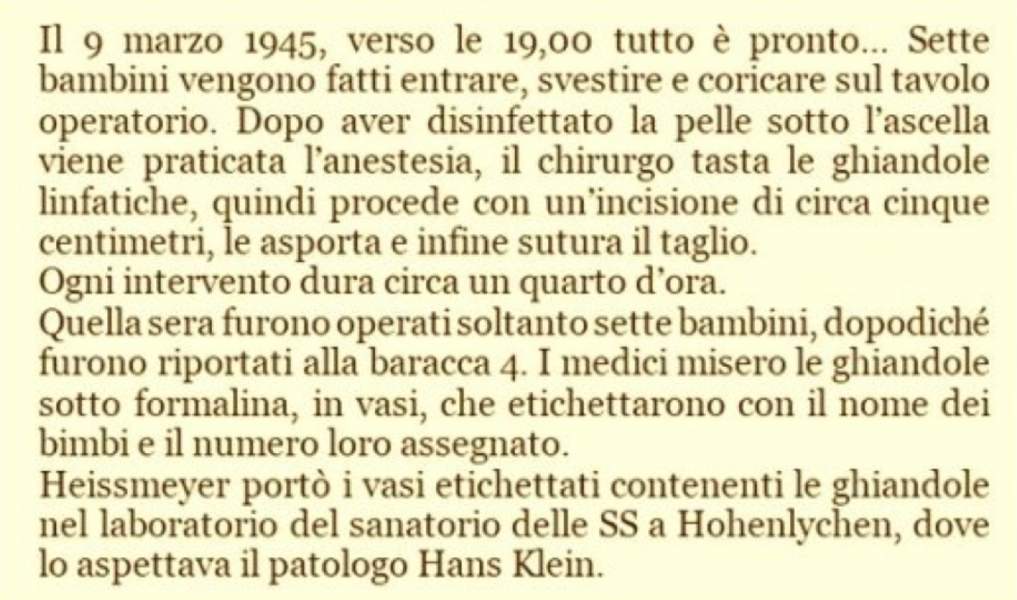“Le donne sono inadatte a scalare montagne. Devono stare tranquille in casa a servire il tè e fare le pulizie.”
Fu per quello che nel 1969 fondai il "Ladies Climbing Club" (LCC) i cui membri erano tutte donne.
Non la presero bene.
I maschietti, intendo.
Fu per quello che nel 1969 fondai il "Ladies Climbing Club" (LCC) i cui membri erano tutte donne.
Non la presero bene.
I maschietti, intendo.
Perché io ero una donna.
E nella società giapponese la donna doveva limitarsi ad accudire la casa e a crescere i figli. Una cosa nuova, vero?
Mi chiamo Junko Tabei, Ishibashi il cognome da ragazza, nata nel 1939 a Miharu, nella prefettura di Fukushima.
E nella società giapponese la donna doveva limitarsi ad accudire la casa e a crescere i figli. Una cosa nuova, vero?
Mi chiamo Junko Tabei, Ishibashi il cognome da ragazza, nata nel 1939 a Miharu, nella prefettura di Fukushima.

Sono cresciuta in una famiglia relativamente povera, condizionata dalla II guerra mondiale. Un famiglia molto numerosa, la più giovane di sette figli.
Quando nacque la mia passione per l’alpinismo?
A 10 anni, durante una gita scolastica sul monte Asahi a 2300 metri di altezza
Quando nacque la mia passione per l’alpinismo?
A 10 anni, durante una gita scolastica sul monte Asahi a 2300 metri di altezza
Ero un vero macho. Alta, grossa...
Dai, non è vero, sto scherzando.
Ero uno scricciolo, alto un metro e cinquantadue e un problema congenito ai polmoni che mi provocava spesso febbre alta. Non ero una grande atleta, ma mi allenavo quotidianamente.
E avevo tanta, tanta volontà.
Dai, non è vero, sto scherzando.
Ero uno scricciolo, alto un metro e cinquantadue e un problema congenito ai polmoni che mi provocava spesso febbre alta. Non ero una grande atleta, ma mi allenavo quotidianamente.
E avevo tanta, tanta volontà.
Studiai per diventare insegnante laureandomi in letteratura inglese a Tokyo.
Ma la passione per le montagne non mi abbandonava.
Fu per quello che fondai quel club per sole donne nel 1969.
“Andiamo a fare una spedizione all’estero, da sole".
Ma la passione per le montagne non mi abbandonava.
Fu per quello che fondai quel club per sole donne nel 1969.
“Andiamo a fare una spedizione all’estero, da sole".
Il sogno di ogni alpinista?
Lei, la montagna più alta del mondo.
Il posto più pericoloso al mondo.
Volevo salire sull'Everest, seguendo la stessa via del neozelandese Edmund Hillary del 29 maggio 1953.

Lei, la montagna più alta del mondo.
Il posto più pericoloso al mondo.
Volevo salire sull'Everest, seguendo la stessa via del neozelandese Edmund Hillary del 29 maggio 1953.


Nel 1970 ero stata la prima donna a raggiungere i 7.555 metri della terza vetta del massiccio dell'Annapurna.
Fu subito dopo che diedi vita al progetto "donne giapponesi per la spedizione sull'Everest" riuscendo ad ottenere dal Nepal il permesso per guidare 15 donne.
Fu subito dopo che diedi vita al progetto "donne giapponesi per la spedizione sull'Everest" riuscendo ad ottenere dal Nepal il permesso per guidare 15 donne.

Ci allenammo cinque anni e nel maggio del 1975 iniziammo la scalata. Eravamo a 6.300 metri quando fummo travolte da una valanga. Nessuna ci rimise la pelle, anche se io svenni per qualche minuto. Ripresi la salita,accompagnata solo dallo sherpa, Ang Tsering. Tutto a posto? Magari
Eravamo arrivati a 8.763 metri.
Il mio caro sherpa non mi aveva avvisata.
Per arrivare alla vetta, 8.848 metri, avrei dovuto superare un costone che formava il confine tra il Nepal e la Cina.
Sbagliando potevo precipitare per 5.000 metri in Cina o 4.700 metri in Nepal
Il mio caro sherpa non mi aveva avvisata.
Per arrivare alla vetta, 8.848 metri, avrei dovuto superare un costone che formava il confine tra il Nepal e la Cina.
Sbagliando potevo precipitare per 5.000 metri in Cina o 4.700 metri in Nepal

Ma ce la feci e diventai la prima donna a scalare l’Everest.
Io Junko Tabei, lo scricciolo.
Era il 16 maggio 1975, 12 giorni dopo la valanga.
Riuscirono a scrivere lo stesso cattiverie. “Scala la vetta e lascia a casa sua figlia con il padre”.
Mio marito era un alpinista.


Io Junko Tabei, lo scricciolo.
Era il 16 maggio 1975, 12 giorni dopo la valanga.
Riuscirono a scrivere lo stesso cattiverie. “Scala la vetta e lascia a casa sua figlia con il padre”.
Mio marito era un alpinista.



Junko Tabei, nel 1991, raggiunse la vetta del Monte Vinson: la cima più alta dell'Antartide. Nel giugno del 1992, salendo il Puncak Jaya in Indonesia, divenne la prima donna a completare le Seven Summits, le montagne più alte per ciascuno dei sette continenti della Terra. 

Nel 2000 completò uno studio all'università di Kyushu sul degrado ambientale dell'Everest, causato dai rifiuti abbandonati dalle spedizioni.
Dalla prima spedizione sull’Everest, al primo campo base a 5.364 metri di quota, gli scalatori hanno scaricato 1,03 milioni/litri di urina
Dalla prima spedizione sull’Everest, al primo campo base a 5.364 metri di quota, gli scalatori hanno scaricato 1,03 milioni/litri di urina
Nessun, problema, se non fosse che gli abitanti dei villaggi ai piedi dell’Everest dipendono dalle acque del disgelo.
Dal 2008 lo sherpa Dawa Steven guida una spedizione annuale per raccogliere tutti i rifiuti.
Ha recuperato già circa 15 tonnellate di rifiuti.
Dal 2008 lo sherpa Dawa Steven guida una spedizione annuale per raccogliere tutti i rifiuti.
Ha recuperato già circa 15 tonnellate di rifiuti.

Junko Tabei, direttrice dell'Himalayan Trust of Japan, ha realizzato un inceneritore per eliminare i rifiuti sull’Everest.
E’ morta il 20/10/2016 a 77 anni.
Qualche mese prima di morire, guidò, sul monte Fuji, un gruppo di giovani, sfollati a seguito del disastro di Fukushima.
E’ morta il 20/10/2016 a 77 anni.
Qualche mese prima di morire, guidò, sul monte Fuji, un gruppo di giovani, sfollati a seguito del disastro di Fukushima.

Grazie a @Ulyfey per avermi chiesto di raccontare la storia di Junko Tabei, che tutti volevano a casa a fare le pulizie.
Lei invece aveva una sola filosofia: vivere la vita al massimo.
Sempre.
Tanto le pulizie possono aspettare.
Lei invece aveva una sola filosofia: vivere la vita al massimo.
Sempre.
Tanto le pulizie possono aspettare.

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh