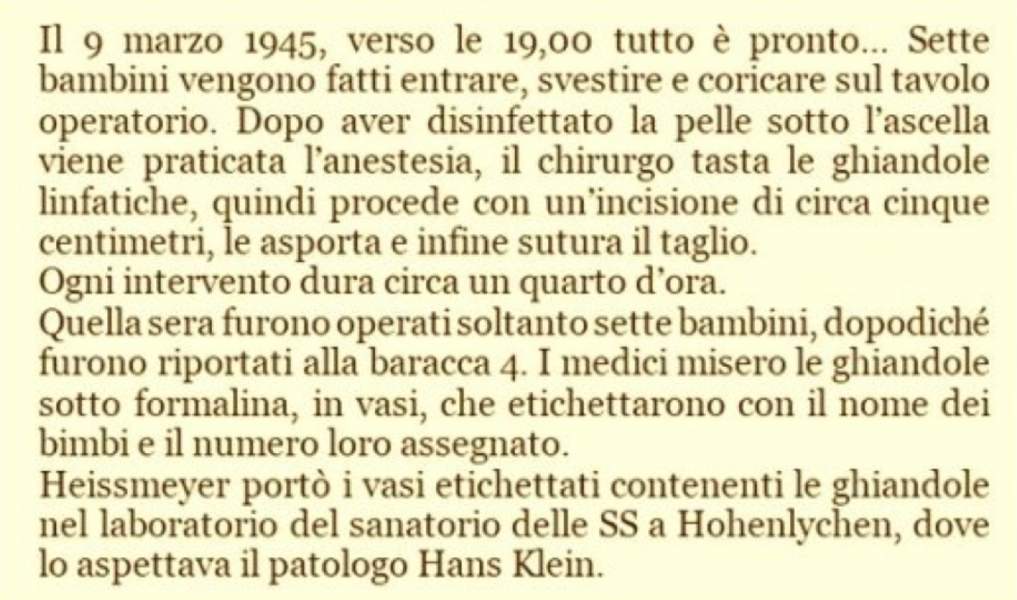Le foto sono del mio collega David Sherman.
Il giorno? Il 30 aprile 1945. Il luogo? Un’abitazione a Monaco, al 16 di Prinzregentenplatz. Io che faccio il bagno. Mentre il proprietario dell’appartamento si toglieva la vita in un bunker di Berlino.

Il giorno? Il 30 aprile 1945. Il luogo? Un’abitazione a Monaco, al 16 di Prinzregentenplatz. Io che faccio il bagno. Mentre il proprietario dell’appartamento si toglieva la vita in un bunker di Berlino.


Non ero in quell’appartamento per caso. Lo avevo fatto intenzionalmente. Volevo lavarmi dallo sporco che mi aveva ricoperta durante la visita al campo di concentramento di Dachau.
Un bagno nella vasca di Hitler.
Un bagno nella vasca di Hitler.

Mi chiamo Lee Miller e sono nata a Poughkeepsie, nello stato di New York il 23 aprile 1907.
Papà Theodore era un inventore tedesco con la passione della fotografia. Una passione che mi aveva trasmesso fin da piccola.
Papà Theodore era un inventore tedesco con la passione della fotografia. Una passione che mi aveva trasmesso fin da piccola.

Già. Fin da piccola. E da piccola subii la violenza che cambiò tutto il mio essere donna. Avevo sette anni. La mamma in ospedale e io affidata ad amici a Brooklyn. La violenza.
E quella maledetta gonorrea che mi trascinai per anni.
E quella maledetta gonorrea che mi trascinai per anni.
Fu in quel preciso momento che, malgrado tutti mi vedessero come un angelo tanto ero bella, diventai un demonio dentro.
Amavo l’arte in genere. Nel 1925 andai a l’École nationale supérieure des beaux-art e poi alla Art Students League di New York per studiare scenografia.
Amavo l’arte in genere. Nel 1925 andai a l’École nationale supérieure des beaux-art e poi alla Art Students League di New York per studiare scenografia.
Fu proprio in quell’anno che la mia vita cambiò. Camminavo a Manhattan.
Fu una fortuna che in quel momento stesse passando accanto a me il signor Condé Nast, editore di Vogue. Che mi afferrò prima che quella macchina mi travolgesse.
Fu una fortuna che in quel momento stesse passando accanto a me il signor Condé Nast, editore di Vogue. Che mi afferrò prima che quella macchina mi travolgesse.
Forse fu il mio fascino. Fatto sta che mi offrì un lavoro come modella. Un caso. Che mi fece diventare la modella più ricercata dai più grandi fotografi di quel tempo.
Da Edward Steichen a Arnold Genthe.
Da Edward Steichen a Arnold Genthe.

Fino al 1928. Quando uno scandalo fece finire la mia carriera di modella. Che avevo fatto di così tanto grave? Una foto che mi ritraeva per una pubblicità di assorbenti.
Per la prima volta una donna pubblicizzava qualcosa di così intimo. Un vero scandalo.
Per la prima volta una donna pubblicizzava qualcosa di così intimo. Un vero scandalo.

Ne fui quasi felice. Cominciava a starmi stretto il ruolo davanti all’obiettivo. Io volevo fotografare. Per questo fuggii a Parigi dove conobbi una grande fotografo, Man Ray. Diventai sua allieva, musa e amante. 

Poi la mia vita prese strade diverse.
Prima uno studio tutto mio a New York poi in Egitto e poi nel 1937 di nuovo a Parigi.
Dove conobbi e mi innamorai di Roland Penrose, pittore e poeta inglese.

Prima uno studio tutto mio a New York poi in Egitto e poi nel 1937 di nuovo a Parigi.
Dove conobbi e mi innamorai di Roland Penrose, pittore e poeta inglese.


Con lui mi stabilii a Londra. Dove scattai quelle foto sotto il blitz delle V2 naziste. Quando lui venne chiamato alle armi diventai una fotoreporter di guerra. Un incarico che difficilmente veniva assegnato ad una donna.
Fu così che vidi l’orrore.

Fu così che vidi l’orrore.


Quando visitai i campi di concentramento di Dachau e Buchenwald, o quando visitai le prigioni della Gestapo.
Sviluppavo personalmente le pellicole in una camera oscura improvvisata nella mia stanza d'albergo.
Sviluppavo personalmente le pellicole in una camera oscura improvvisata nella mia stanza d'albergo.

Ero fotoreporter di guerra per Vogue. Mi chiesero più volte se quello che vedevano nelle foto fosse reale. Era tutto vero. Avevo solo impresso sulle pellicole tutte le mostruosità di cui è capace l’uomo.
Un incubo per una come me.
Un incubo per una come me.

Un incubo che sconvolse la vita di Lee Miller. Aveva quarant’anni quando iniziò a bere, soffrire di insonnia e di depressione nonostante la nascita di Anthony.
Il tradimento del marito e l’accusa di essere una spia sovietica segneranno il resto della sua vita.

Il tradimento del marito e l’accusa di essere una spia sovietica segneranno il resto della sua vita.


Lee Miller morirà il 21 luglio 1977 dimenticata da tutti. Lei, una delle più grandi figure femminili della fotografia. Le ceneri sparse nel suo giardino. Il figlio Anthony ha scritto la biografia di sua madre "The Lives of Lee Miller” impegnandosi a promuovere l’opera materna. 



• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh