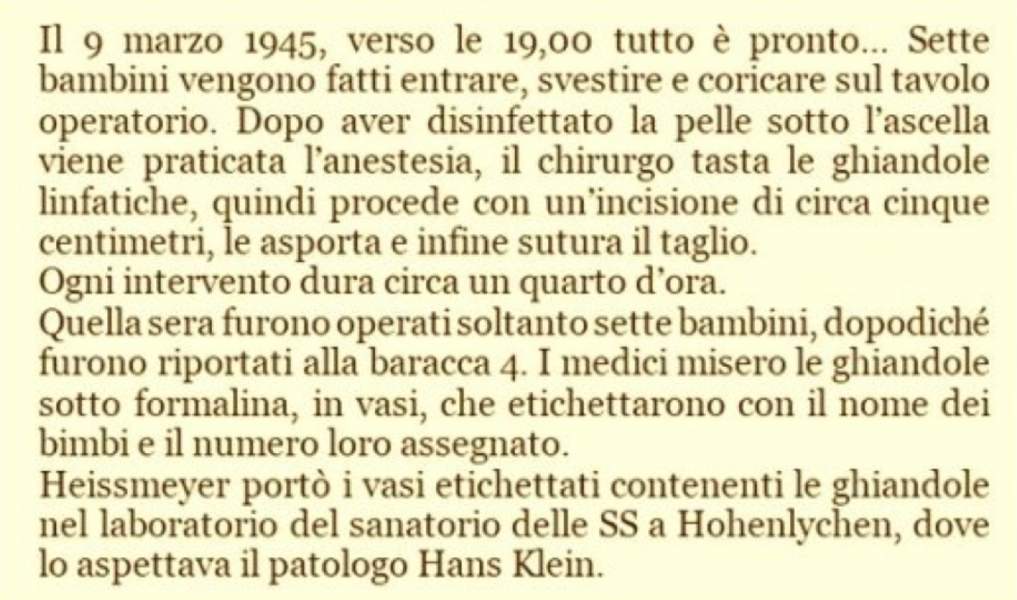Mi ero sposata giovane, a 19 anni. Lui, un violento, mi picchiava spesso, mentre nell’Ohio lavoravo i campi e crescevo 11 figli. Mi chiamo Emma Rowena Gatewood e riuscii divorziare da quell’uomo violento solo nel 1940 malgrado le sue minacce di farmi rinchiudere in manicomio. 

Avevo 67 anni in quel freddo giorno di aprile del 1955. Quando presi quella decisione.
Dissi ai miei figli, ormai adulti, che sarei andata a fare una passeggiata. Va bene, mi dissero. Mai immaginando cosa stavo per fare. Con pochi soldi in tasca e qualche indumento in uno zaino.

Dissi ai miei figli, ormai adulti, che sarei andata a fare una passeggiata. Va bene, mi dissero. Mai immaginando cosa stavo per fare. Con pochi soldi in tasca e qualche indumento in uno zaino.


Io invece lo sapevo benissimo.
Avevo letto sul National Geographic un articolo che parlava del "Sentiero degli Appalachi". Lungo 3.510 chilometri si snodava fra 13 stati sulla costa orientale degli Stati Uniti.
Ecco quello che avevo deciso di fare. Percorrere quei 3.510 km.
Avevo letto sul National Geographic un articolo che parlava del "Sentiero degli Appalachi". Lungo 3.510 chilometri si snodava fra 13 stati sulla costa orientale degli Stati Uniti.
Ecco quello che avevo deciso di fare. Percorrere quei 3.510 km.

Nessuna donna aveva mai completato quel percorso. Per me, abituata a camminare, sembrava invece una cosa semplice. Almeno da come era illustrato sulla rivista. Una tranquilla passeggiata con punti di ritrovo alla fine di ogni giornata.
Vi garantisco che non fu per niente facile.
Vi garantisco che non fu per niente facile.

Prima di tutto non fu una grande idea partire con ai piedi un paio di scarpe Converse.
Senza un sacco a pelo e senza una tenda poteva anche passare, ma non avevo nemmeno una mappa o una bussola.
Avevo nella borsa solo una coperta di lana, un impermeabile e una tenda da doccia.

Senza un sacco a pelo e senza una tenda poteva anche passare, ma non avevo nemmeno una mappa o una bussola.
Avevo nella borsa solo una coperta di lana, un impermeabile e una tenda da doccia.


In realtà avevo anche cerotti, forcine, acqua, coltellino, torcia, caramelle alla menta, penna, taccuino da 25 centesimi, würstel, uva, noccioline e latte in polvere.
Non fu tanto il ginocchio infermo a crearmi problemi.
E neppure il fatto che senza occhiali non vedevo niente.
Non fu tanto il ginocchio infermo a crearmi problemi.
E neppure il fatto che senza occhiali non vedevo niente.

La cosa più difficile fu salire il monte Katahdin, la vetta più elevata di tutto il percorso. Pensate. Mi sono pure persa. Eppure dovevo solo seguire i segni bianchi sul sentiero. E poi gli occhiali rotti, il cibo finito.
Fortunatamente ogni volta mi recuperavano i ranger.
Fortunatamente ogni volta mi recuperavano i ranger.

Malgrado tutte queste disavventure, fui la prima donna a percorrere tutto l’Appalachian Trail in una stagione.
La quinta persona in assoluto.
Nessuno mi aveva avvisata di tutti i pericoli di quella camminata.
Per esempio i serpenti velenosi.
La quinta persona in assoluto.
Nessuno mi aveva avvisata di tutti i pericoli di quella camminata.
Per esempio i serpenti velenosi.

Anche se poi alla fine furono le zecche, le zanzare e insetti vari a darmi più fastidio. Incontrai anche un orso nero americano. Come sono riuscita a spaventarlo?
Quando hai avuto a che fare per una vita con una mandria di 11 figli e 23 nipoti che volete che sia un vecchio orso.
Quando hai avuto a che fare per una vita con una mandria di 11 figli e 23 nipoti che volete che sia un vecchio orso.

Diventai una celebrità e per tutti diventai Nonna Gatewood. Non mi fermai lì.
Rifeci il percorso nel 1960 e nel 1963, a 75 anni. L’unica a percorrere l’Appalachian Trail per tre volte. Di più.
Attraversai tutti gli stati lungo i 3200 chilometri anche dell’Oregon Trail. Perché?

Rifeci il percorso nel 1960 e nel 1963, a 75 anni. L’unica a percorrere l’Appalachian Trail per tre volte. Di più.
Attraversai tutti gli stati lungo i 3200 chilometri anche dell’Oregon Trail. Perché?


Perché non importa quanti anni hai.
Quello che conta è la volontà, che va oltre l’età anagrafica. Quindi se avete un sogno, un desiderio, una cosa che vorreste fare, fatela. Per poter dire come me: “Ho detto che lo avrei fatto, e l’ho fatto”.
Ehi, che aspettate?
Quello che conta è la volontà, che va oltre l’età anagrafica. Quindi se avete un sogno, un desiderio, una cosa che vorreste fare, fatela. Per poter dire come me: “Ho detto che lo avrei fatto, e l’ho fatto”.
Ehi, che aspettate?

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh