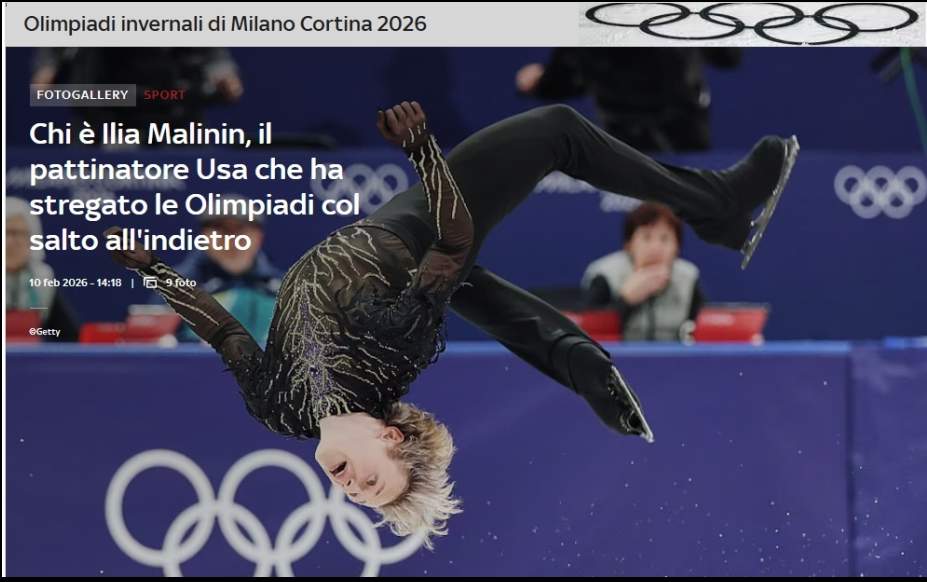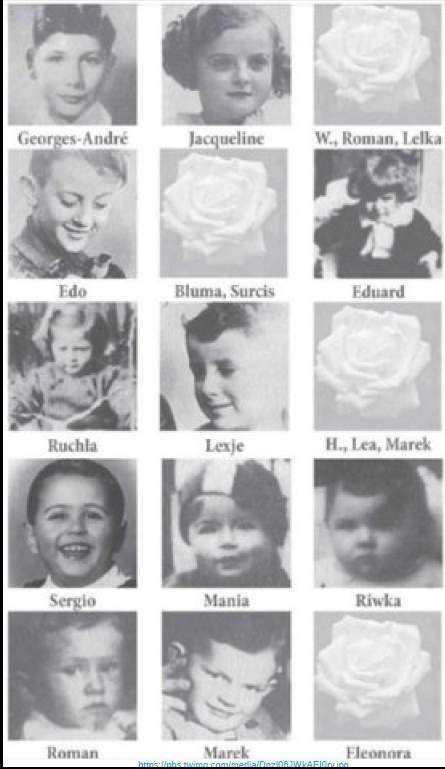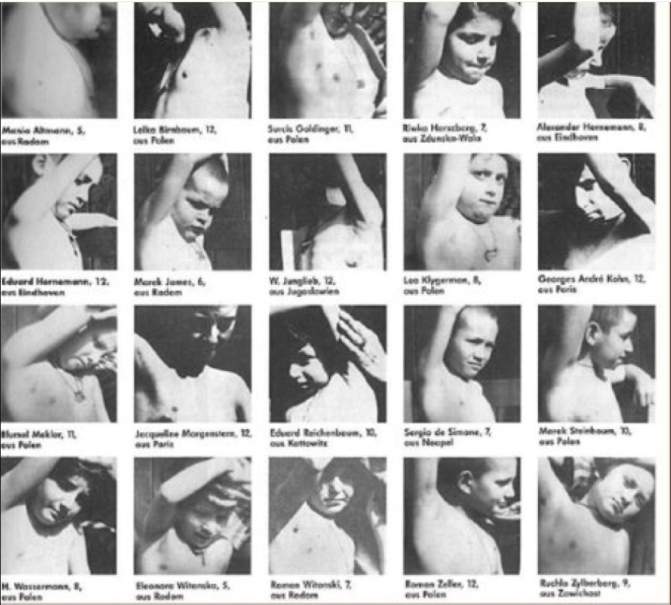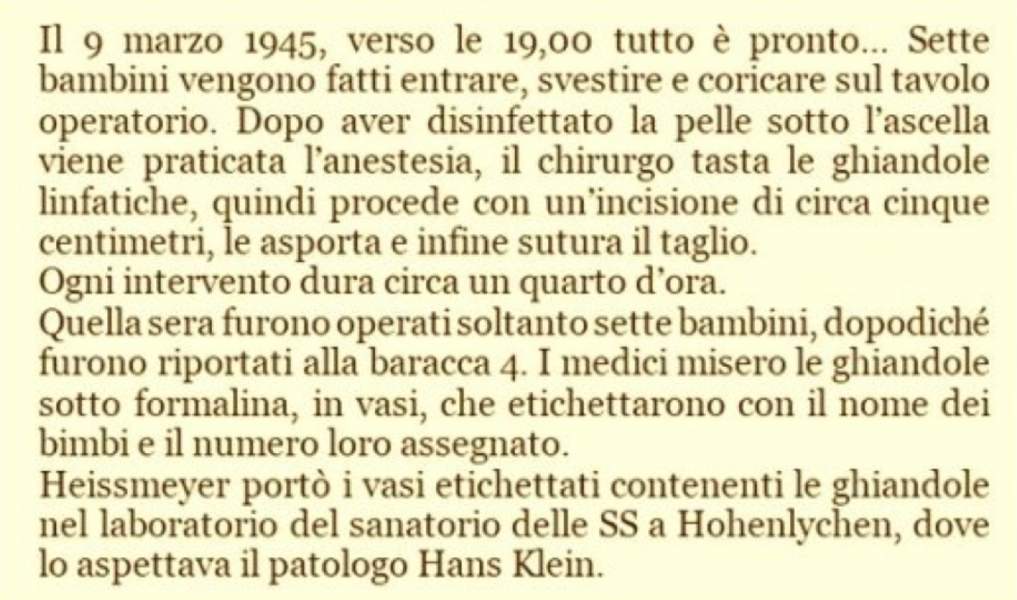Oggi è il 16 marzo 2005. E sono stanca.
Ho nausea, vomito e diverse linee di febbre. Speriamo bene. E’ tutto il giorno che penso a lui, al dottor Matthew Lukwiya.
Non sono certo alla sua altezza.
Io sono solo pediatra presso l'ospedale di Uíge in Angola.
Ho nausea, vomito e diverse linee di febbre. Speriamo bene. E’ tutto il giorno che penso a lui, al dottor Matthew Lukwiya.
Non sono certo alla sua altezza.
Io sono solo pediatra presso l'ospedale di Uíge in Angola.
Invece nel 2000 il dottor Lukwiya era Dirigente Sanitario all’ Hospital Lacor, in Uganda. Quando la gente cominciò a morire per gravi emorragie interne, di una malattia misteriosa. E non era certo una bella cosa quell’usanza di lavare i morti.Contribuiva a diffondere la malattia
Fu lui a riconoscere la gravità della situazione e la facilità di trasmissione del virus.
Fu lui a ignorare le pratiche burocratiche e a far analizzare subito il sangue infetto.
Ebola, fu il risultato. E il suo impegno a isolare l’ospedale. A proteggere il personale medico.
Fu lui a ignorare le pratiche burocratiche e a far analizzare subito il sangue infetto.
Ebola, fu il risultato. E il suo impegno a isolare l’ospedale. A proteggere il personale medico.

I medici e gli infermieri avevano paura. Continuavano a morire, ma lui li esortava, sempre in prima fila. Fino a contagiarsi.
Fu la cento sessantaseiesima vittima di Ebola. Ricordo ancora quel 5 dicembre del 2000 e il dolore per la sua morte.
Fu la cento sessantaseiesima vittima di Ebola. Ricordo ancora quel 5 dicembre del 2000 e il dolore per la sua morte.
E' ricordando il lavoro del medico ugandese Matthew Lukwiya che il pensiero corre alla mia infanzia. Ne ho fatta di strada prima di arrivare qui in Africa. Ma era scritto. Era stata da sempre la mia vocazione.
Sono nata a Biella il 9 dicembre 1953.
Sono nata a Biella il 9 dicembre 1953.

Nel 1978 la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino e in seguito il diploma di Medicina Tropicale ad Anversa, nel 1984.
Intercalando mesi di volontariato in Africa. Presso l'Ospedale di Ikonda (Tanzania) come responsabile del reparto pediatrico
Intercalando mesi di volontariato in Africa. Presso l'Ospedale di Ikonda (Tanzania) come responsabile del reparto pediatrico
Ci tornavo spesso in Africa come volontaria. Due anni come responsabile del reparto di pediatria ed unità bambini malnutriti presso l'ospedale regionale di Tenkodogo in Burkina Faso.
Passando dall’ospedale regionale di Iringa in Tanzania ero arrivata al St. Mary Hospital Lacor.
Passando dall’ospedale regionale di Iringa in Tanzania ero arrivata al St. Mary Hospital Lacor.

L’ospedale dove aveva lavorato il dottor Matthew Lukwiya. E due anni fa sono arrivata qui, all’ospedale provinciale di Uíge in Angola. E' stato nell’ottobre del 2004 che ho denunciato la comparsa di quelle morti sospette. Con febbre emorragica. 

Avevo inviato subito campioni ai tecnici del Ministero della Sanità nella capitale Luanda. Ma senza risposta. C’era voluta la morte di un’infermiera per svegliarli.
Solo il mese scorso mi hanno autorizzato ad aprire due locali di isolamento infettivo.
Solo il mese scorso mi hanno autorizzato ad aprire due locali di isolamento infettivo.
Poveri bambini. Ne sono già morti 90. Virus di Marburg lo chiamano. Simile all’Ebola. Mi dicono tutti di stare attenta. Ma Matthew Lukwiya diceva che “salvare vite è la nostra vocazione. Comporta dei rischi, ma se ami veramente il tuo lavoro il rischio non conta poi così tanto”.
Di più. ” Se io lasciassi in questo momento, non potrei più esercitare la professione medica nella mia vita. Non avrebbe più senso per me”. Aveva ragione, sapete. E’ così per tutti noi che amiamo questo lavoro.
“Se la mia morte fosse l’ultima non mi dispiacerebbe morire”.
“Se la mia morte fosse l’ultima non mi dispiacerebbe morire”.
Il 16 marzo 2005 Maria Bonino era stanca, con nausea, vomito e diverse linee di febbre . Aveva contratto il Virus di Marburg. Morirà il 24 marzo 2005 a Luanda all'età di 51 anni. Nella sua Africa, che tanto amava.
È sepolta in un cimitero angolano.
"Se morirò lasciatemi qui"
È sepolta in un cimitero angolano.
"Se morirò lasciatemi qui"

“Ho la febbre e mi sento tutta rotta. Speriamo che sia malaria. E se no…mi dispiace di morire, mi dispiace per me, per il dolore della mamma, della Cri, del Paolo, dei miei nipoti e dei miei cognati, delle persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene.”
(Maria Bonino)
(Maria Bonino)

Maria Bonino ha lavorato anche al St. Mary Hospital Lacor. Dove lavorava il medico ugandese Matthew Lukwiya. Il St. Mary Hospital Lacor, fondato nel 1959 dai missionari comboniani, è stata gestito e sviluppato dal 1961 dai coniugi Piero Corti e dalla moglie, Lucille Teasdale. 



Piero pediatra, e Lucille chirurgo, hanno continuato a lavorarci fino alla loro morte.
Lei nel 1996, dopo aver contratto l’AIDS durante un’operazione chirurgica.
Lui ci ha lasciato nel 2003.
E’ considerato il più grande ospedale senza scopo di lucro dell'Africa orientale.

Lei nel 1996, dopo aver contratto l’AIDS durante un’operazione chirurgica.
Lui ci ha lasciato nel 2003.
E’ considerato il più grande ospedale senza scopo di lucro dell'Africa orientale.


Nel 2016/17 effettuati 34.600 ricoveri, e 149.649 prestazioni ambulatoriali.
I pazienti sono curati gratuitamente o a tariffe bassissime.
"Perché un ospedale deve offrire il miglior servizio possibile al maggior numero di persone al più basso costo possibile” (Piero Corti).
I pazienti sono curati gratuitamente o a tariffe bassissime.
"Perché un ospedale deve offrire il miglior servizio possibile al maggior numero di persone al più basso costo possibile” (Piero Corti).

Grazie a @AvvDox per avermi suggerito di raccontare la storia di Maria Bonino, volontaria per quasi undici anni con “Medici per l’Africa Cuamm”.
Maria, che come tanti altri medici, non si è tirata indietro.
Morti, perché quella professione l'amavano più della loro stessa vita.
Maria, che come tanti altri medici, non si è tirata indietro.
Morti, perché quella professione l'amavano più della loro stessa vita.

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh