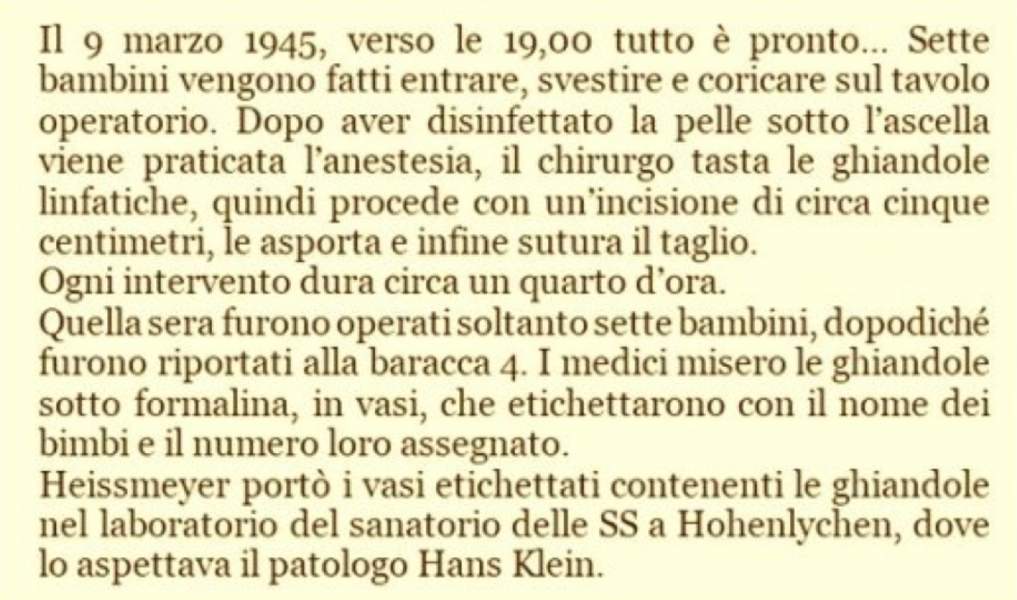“Le dittature, tanto di destra come di sinistra, non mi sono mai andate a genio. Purtroppo ci sono persone a cui piacciono i dittatori”.
Non mi tirai indietro quando fu indetto quel referendum. L’esito era incerto. Io molto conosciuto.
"Rey del metro cuadrado" mi chiamavano.

Non mi tirai indietro quando fu indetto quel referendum. L’esito era incerto. Io molto conosciuto.
"Rey del metro cuadrado" mi chiamavano.


Era il 1988 e il mio Paese, il Cile, da anni era un paese triste, che non sorrideva più.
Molti sparivano nel nulla. La tortura all’ordine del giorno. Una continua violazione dei diritti umani.
Per quello intervenni in quel referendum, schierandomi pubblicamente per il NO.
Molti sparivano nel nulla. La tortura all’ordine del giorno. Una continua violazione dei diritti umani.
Per quello intervenni in quel referendum, schierandomi pubblicamente per il NO.

La Costituzione entrata in vigore nel 1981 stabiliva che fosse effettuato un referendum al termine del primo mandato presidenziale.
Votare "SI" significava confermare Pinochet, il "No" avrebbe portato a nuove elezioni.
Come potevo tirarmi indietro?
Non lo avevo mai fatto.
Votare "SI" significava confermare Pinochet, il "No" avrebbe portato a nuove elezioni.
Come potevo tirarmi indietro?
Non lo avevo mai fatto.

Fin dall’inizio, da quell' 11 settembre 1973.
Ci dovevamo radunare al campo di allenamento Juan Pinto Durán in vista dei mondiali.
Una volta arrivati il commissario tecnico ci disse di tornare a casa.
Capimmo lungo la strada quello che stava accadendo.
Ci dovevamo radunare al campo di allenamento Juan Pinto Durán in vista dei mondiali.
Una volta arrivati il commissario tecnico ci disse di tornare a casa.
Capimmo lungo la strada quello che stava accadendo.

C’erano soldati dappertutto.
La gente veniva arrestata.
E poi i caccia Hawker Hunter di fabbricazione britannica, con bombe incendiarie, sul Palacio de la Moneda dove aveva sede il governo democratico di Salvador Allende
La gente veniva arrestata.
E poi i caccia Hawker Hunter di fabbricazione britannica, con bombe incendiarie, sul Palacio de la Moneda dove aveva sede il governo democratico di Salvador Allende

Alle elezioni del 1973 avevo votato e appoggiato il Partido Comunista che sosteneva Allende.
Di lui dissi: “Aveva i suoi difetti, come tutti, però era una brava persona che voleva fare del Cile un grande paese”.
Di lui dissi: “Aveva i suoi difetti, come tutti, però era una brava persona che voleva fare del Cile un grande paese”.

Questa premessa era necessaria per poter parlare di una partita.
Uno spareggio tra noi e l’URSS che avrebbe consentito al Cile di andare ai mondiali di Germania del 1974.
All’andata era finita 0-0.
Il ritorno era previsto in casa, allo stadio nazionale di Santiago.
Uno spareggio tra noi e l’URSS che avrebbe consentito al Cile di andare ai mondiali di Germania del 1974.
All’andata era finita 0-0.
Il ritorno era previsto in casa, allo stadio nazionale di Santiago.
Uno stadio magico per il calcio, diventato in quei giorni un campo di concentramento a cielo aperto con gli spogliatoi usati per le fucilazioni.
Lo sapevamo tutti. Lo sapeva il mondo intero.
Per quello l’URSS si rifiutò di venire a giocare il ritorno. Volevano un campo neutro.

Lo sapevamo tutti. Lo sapeva il mondo intero.
Per quello l’URSS si rifiutò di venire a giocare il ritorno. Volevano un campo neutro.


La FIFA si rifiutò.
“Siamo a andati visitare lo stadio ed è tutto a posto”, dissero.Nessun dissidente prigioniero. I sovietici si sono inventati tutto. Già. Scopriranno anni dopo la verità. Con i prigionieri nascosti negli anfratti e nei sotterranei dello stadio durante la visita

“Siamo a andati visitare lo stadio ed è tutto a posto”, dissero.Nessun dissidente prigioniero. I sovietici si sono inventati tutto. Già. Scopriranno anni dopo la verità. Con i prigionieri nascosti negli anfratti e nei sotterranei dello stadio durante la visita


I sovietici si rifiutarono comunque di giocare.
Eravamo qualificati.
Ma Pinochet voleva di più.
Il 21 novembre 1973 venimmo convocati per una partita. Con l’URSS.
Ma quale partita se i sovietici sono rimasti a Mosca?
Lo capimmo appena scesi in campo

Eravamo qualificati.
Ma Pinochet voleva di più.
Il 21 novembre 1973 venimmo convocati per una partita. Con l’URSS.
Ma quale partita se i sovietici sono rimasti a Mosca?
Lo capimmo appena scesi in campo


I militari avevano riempito lo stadio di tifosi.
Con la forza.
C’era tutto ciò che serviva per disputare una partita di quel genere.
Noi, giocatori del Cile, i tifosi e persino l’arbitro, Rafael Hormazábal.
E c’era Pinochet in tribuna. Con tutti i militari.
Con la forza.
C’era tutto ciò che serviva per disputare una partita di quel genere.
Noi, giocatori del Cile, i tifosi e persino l’arbitro, Rafael Hormazábal.
E c’era Pinochet in tribuna. Con tutti i militari.
Il tabellone indicava la partita della qualificazione ai mondiali tra Cile e URSS.
C’era tutto. O meglio.
Quasi tutto. Mancava solo una piccola cosa.
In verità nemmeno tanto piccola.
Mancava la squadra avversaria.
Era stato Pinochet a mettere in scena quella farsa.
C’era tutto. O meglio.
Quasi tutto. Mancava solo una piccola cosa.
In verità nemmeno tanto piccola.
Mancava la squadra avversaria.
Era stato Pinochet a mettere in scena quella farsa.

Finì 1-0.
Avevo la palla, avrei voluto scagliarla lontano.
Invece la passai al capitano Francisco El Chamaco Valdés, figlio di operai, e militante di sinistra, che la mise in rete.
Per Pinochet un successo.
bit.ly/3CF4McD
Avevo la palla, avrei voluto scagliarla lontano.
Invece la passai al capitano Francisco El Chamaco Valdés, figlio di operai, e militante di sinistra, che la mise in rete.
Per Pinochet un successo.
bit.ly/3CF4McD
Quando poi Pinochet ci invitò nel palazzo Diego Portales, poco prima della partenza per la Germania, i miei compagni gli strinsero la mano.
“Avevo paura, ma lo dovevo fare".
Rifiutai di porgergli la mano.
E la pagai cara.
“Avevo paura, ma lo dovevo fare".
Rifiutai di porgergli la mano.
E la pagai cara.
Dopo quei mondiali la mia avversione a Pinochet mi chiuse tutte le porte alla nazionale per qualche anno.
Fino ad arrivare a quella dichiarazione per il NO al referendum.
Fu in TV, quando una donna confessò di essere stata arrestata e torturata.
Fu lì che intervenni.
Fino ad arrivare a quella dichiarazione per il NO al referendum.
Fu in TV, quando una donna confessò di essere stata arrestata e torturata.
Fu lì che intervenni.

Come andò quel referendum?
Vinse il "NO", anche se con solo il 55,99%.
Quel NO mise fine alla dittatura, costringendo Pinochet ad elezioni democratiche nel 1989.
Il "SI" al 44,01% dimostrò che “purtroppo ci sono ancora troppe persone a cui piacciono i dittatori”

Vinse il "NO", anche se con solo il 55,99%.
Quel NO mise fine alla dittatura, costringendo Pinochet ad elezioni democratiche nel 1989.
Il "SI" al 44,01% dimostrò che “purtroppo ci sono ancora troppe persone a cui piacciono i dittatori”


Mi chiamo Carlos Caszely, detto il "Rey del metro cuadrado". Calciatore del Cile.
Chi era la donna andata in TV a denunciare di essere stata sequestrata e torturata?
Quella sconosciuta e graziosa signora si chiamava Olga Garrido.
Mia madre.
Chi era la donna andata in TV a denunciare di essere stata sequestrata e torturata?
Quella sconosciuta e graziosa signora si chiamava Olga Garrido.
Mia madre.

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh