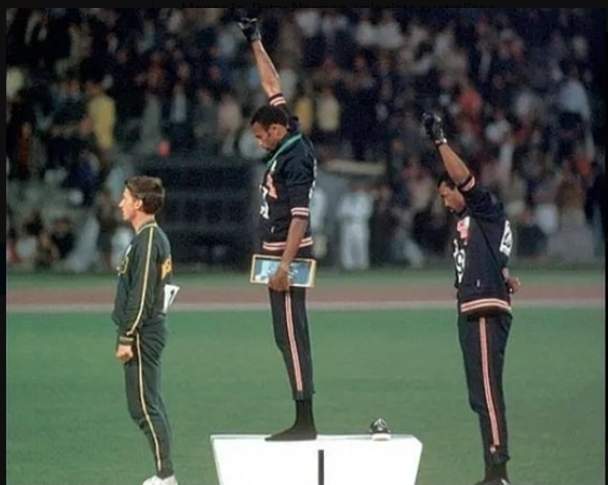Quando arrivarono nella nostra terra fecero esattamente quello che avevano fatto con i nativi americani.
Ma i nativi americani erano anche guerrieri e con loro la cosa andò per le lunghe.
Con noi aborigeni la cosa fu molto più veloce.
La nostra distruzione, intendo.

Ma i nativi americani erano anche guerrieri e con loro la cosa andò per le lunghe.
Con noi aborigeni la cosa fu molto più veloce.
La nostra distruzione, intendo.


Tutto era iniziato nel 1770 quando l’esploratore James Cook era sbarcato a Botany Bay.
Diciotto anni dopo il nostro territorio era stato ritenuto colonizzabile.
«Terra Nullius», avevano dichiarato.
Dal diritto romano "terra che non appartiene a nessuno".
Già.
Diciotto anni dopo il nostro territorio era stato ritenuto colonizzabile.
«Terra Nullius», avevano dichiarato.
Dal diritto romano "terra che non appartiene a nessuno".
Già.

“Terra che non appartiene a nessuno”, inabitata. Peccato che noi eravamo lì da almeno 50.000 anni. Certo, un milione e mezzo di esseri umani in quella terra sconfinata parevano pochi.
Ma era la nostra terra.
Anche se per la nostra cultura non esisteva la “proprietà privata”
Ma era la nostra terra.
Anche se per la nostra cultura non esisteva la “proprietà privata”
Eravamo nomadi, certo, ma tornavano ciclicamente nei nostri luoghi di origine.
Non avevamo case, dormivamo per terra sotto gli alberi o tra i cespugli, ma proprio quegli alberi, cespugli, rocce, fiumi e cascate erano la nostra identità sociale e religiosa.
Non avevamo case, dormivamo per terra sotto gli alberi o tra i cespugli, ma proprio quegli alberi, cespugli, rocce, fiumi e cascate erano la nostra identità sociale e religiosa.

Eravamo dei primitivi secondo i vostri standard.
Non usavamo indumenti ed eravamo brutti, ignoranti, sporchi e miserabili pure per loro.
Ma ripeto.
Eravamo lì da 50.000 anni.
E nessuna legge poteva cambiare le cose.
Quella terra era la nostra terra.
Non usavamo indumenti ed eravamo brutti, ignoranti, sporchi e miserabili pure per loro.
Ma ripeto.
Eravamo lì da 50.000 anni.
E nessuna legge poteva cambiare le cose.
Quella terra era la nostra terra.

Sapete come è andata?
Ci portarono via la terra.
E quindi niente più cibo.
E poi ci massacrarono.
Per farci abbandonare la nostra terra avvelenarono il nostro cibo e la nostra acqua.
Varicella, vaiolo, influenza, malattie veneree e morbillo, allora sconosciuti, fecero il resto.
Ci portarono via la terra.
E quindi niente più cibo.
E poi ci massacrarono.
Per farci abbandonare la nostra terra avvelenarono il nostro cibo e la nostra acqua.
Varicella, vaiolo, influenza, malattie veneree e morbillo, allora sconosciuti, fecero il resto.

Tra il XIX secolo e il XX secolo il 90% della nostra popolazione è stata decimata.
L'indipendenza dell'Australia dal Regno Unito non cambiò lo stato delle cose.
A loro serviva manodopera.
E così uomini, donne e bambini diventarono schiavi a buon mercato.
L'indipendenza dell'Australia dal Regno Unito non cambiò lo stato delle cose.
A loro serviva manodopera.
E così uomini, donne e bambini diventarono schiavi a buon mercato.

E poi quel periodo.
Quello delle Stolen generations (Generazioni rubate). L’allontanamento forzato dei bambini dalle loro famiglie in apposite strutture rieducative per l’apprendimento della lingua e dei costumi britannici. Un trauma per quei bambini, allontanati dalle famiglie.
Quello delle Stolen generations (Generazioni rubate). L’allontanamento forzato dei bambini dalle loro famiglie in apposite strutture rieducative per l’apprendimento della lingua e dei costumi britannici. Un trauma per quei bambini, allontanati dalle famiglie.

La situazione oggi?
Molte famiglie aborigene vivono in uno stato di povertà assoluta.
Di solito in piccole comunità nelle città principali, dedite all’uso di alcol e droghe.
Abbandonate dallo Stato.
Molte famiglie aborigene vivono in uno stato di povertà assoluta.
Di solito in piccole comunità nelle città principali, dedite all’uso di alcol e droghe.
Abbandonate dallo Stato.
Sono stati oltre 100mila i bambini sottratti alle loro famiglie.
Oggi gli Aborigeni hanno 6 volte più probabilità di morire in età infantile rispetto agli altri cittadini australiani.
La loro aspettativa di vita alla nascita è di 17/20 anni inferiore al resto della popolazione.
Oggi gli Aborigeni hanno 6 volte più probabilità di morire in età infantile rispetto agli altri cittadini australiani.
La loro aspettativa di vita alla nascita è di 17/20 anni inferiore al resto della popolazione.
Negli ultimi anni, tra gli aborigeni, è in corso la più tremenda “epidemia” di suicidi.
Il 68% delle vittime ha meno di 30 anni e per il 27% meno di 20.
Nei 2019 ha fatto scalpore il suicidio di tre bambini di soli 12 anni.
Il 68% delle vittime ha meno di 30 anni e per il 27% meno di 20.
Nei 2019 ha fatto scalpore il suicidio di tre bambini di soli 12 anni.
E' stato abolito il 50% dei pagamenti del welfare, sospesa la legge sulla discriminazione razziale e imposti per i bambini aborigeni controlli sanitari obbligatori senza consultare i genitori.
Erano 600 i dialetti parlati dagli aborigeni prima dell’invasione inglese.
Sono 60 quelli sopravvissuti dopo la colonizzazione. La bandiera aborigena è formata dal nero, colore della loro pelle, dal rosso, il colore della terra e da un cerchio giallo che rappresenta il sole.
Sono 60 quelli sopravvissuti dopo la colonizzazione. La bandiera aborigena è formata dal nero, colore della loro pelle, dal rosso, il colore della terra e da un cerchio giallo che rappresenta il sole.

Ricordate la «Terra Nullius», terra che non appartiene a nessuno?
Il principio è rimasto legalmente in vigore fino al 1992 e oggi gli Aborigeni stanno ancora aspettando la restituzione della maggior parte delle loro terre.
Che non avverrà mai.
Il principio è rimasto legalmente in vigore fino al 1992 e oggi gli Aborigeni stanno ancora aspettando la restituzione della maggior parte delle loro terre.
Che non avverrà mai.
Il 26 gennaio, in Australia si festeggia l’Australia Day, l’anniversario dell'arrivo nel 1788 della prima flotta di navi britanniche
l’Australia Day o Invasion day?
Dimenticavo Aborigeno significa “Che è originario del luogo in cui vive”.
Ecco, appunto.
l’Australia Day o Invasion day?
Dimenticavo Aborigeno significa “Che è originario del luogo in cui vive”.
Ecco, appunto.

L’Australia nel 2023 voterà (forse) in un referendum per decidere se modificare la propria Costituzione. Per inserire un articolo che dia “voce” alla popolazione aborigena nel consigliare la politica del governo.
Se la proposta verrà approvata si chiamerà “The Voice” (La Voce).
Se la proposta verrà approvata si chiamerà “The Voice” (La Voce).
«Se provi a venire in Australia in barca, anche se pensiamo che tu sia la persona migliore del mondo, non ti lasceremo entrare».
La terra è nostra, dicono oggi quelli arrivati dal mare nel 1770.
Malgrado gli aborigeni fossero lì da 50.000 anni.
La terra è nostra, dicono oggi quelli arrivati dal mare nel 1770.
Malgrado gli aborigeni fossero lì da 50.000 anni.

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh