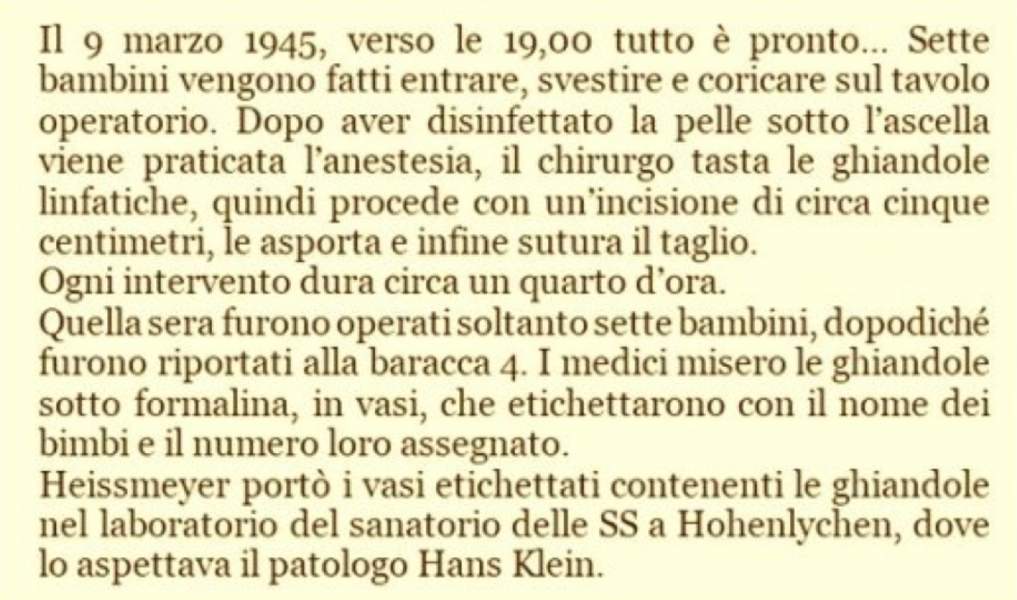Mi chiamo "Pieterson".
In realtà il cognome originale della mia famiglia è "Pitso", trasformato in "Pieterson" nel tentativo di passare dallo status legale di "neri" a quello di "coloured" (meticci).
Che volete.
Pure questo dovevamo subire pur di avere una vita dignitosa.
In realtà il cognome originale della mia famiglia è "Pitso", trasformato in "Pieterson" nel tentativo di passare dallo status legale di "neri" a quello di "coloured" (meticci).
Che volete.
Pure questo dovevamo subire pur di avere una vita dignitosa.
Cosa provocò gli incidenti del giugno del 1976?
Fu colpa del ministro sudafricano dell'istruzione.
Tempo prima aveva emanato un decreto che rendeva obbligatorio l'uso dell'Afrikaans (una lingua figlia dell’olandese) come mezzo di istruzione nelle nostre scuole.
Dei neri intendo.
Fu colpa del ministro sudafricano dell'istruzione.
Tempo prima aveva emanato un decreto che rendeva obbligatorio l'uso dell'Afrikaans (una lingua figlia dell’olandese) come mezzo di istruzione nelle nostre scuole.
Dei neri intendo.
Perché lo fece senza consultare il popolo africano?
Perché secondo lui si doveva parlare solo afrikaans perché i "capi" parlavano quella lingua.
"Se gli studenti non sono contenti, stiano pure lontano da scuola poiché la frequenza non è obbligatoria per i neri".
Già.
Perché secondo lui si doveva parlare solo afrikaans perché i "capi" parlavano quella lingua.
"Se gli studenti non sono contenti, stiano pure lontano da scuola poiché la frequenza non è obbligatoria per i neri".
Già.
Scusate, ma vi sembra giusto che sia sovvenzionata dal governo solo la scuola dei bianchi mentre i genitori neri devono pagare un mese di stipendio all’anno per mandare i figli a scuola?
E noi neri dobbiamo comprare i libri di testo, mentre per i bianchi sono gratis?
E noi neri dobbiamo comprare i libri di testo, mentre per i bianchi sono gratis?
Comunque.
Tutto iniziò il 1º gennaio 1975 quando tutti i presidi delle scuole nere ricevettero ordine di usare l'afrikaans nelle lezioni.
L’ultimo episodio di una lunga serie.
Dopo aver perso gradualmente molti altri diritti ci obbligavano a parlare"la lingua degli oppressori"
Tutto iniziò il 1º gennaio 1975 quando tutti i presidi delle scuole nere ricevettero ordine di usare l'afrikaans nelle lezioni.
L’ultimo episodio di una lunga serie.
Dopo aver perso gradualmente molti altri diritti ci obbligavano a parlare"la lingua degli oppressori"

Era il 16 giugno e faceva freddo nella township di Soweto, quando 20.000 studenti uscirono dalle scuole per una grande manifestazione.
Io, Hector Pieterson, ero in mezzo a loro.
Una manifestazione pacifica.
Davanti avevamo cartelli con scritto: “Non sparateci, non siamo armati"
Io, Hector Pieterson, ero in mezzo a loro.
Una manifestazione pacifica.
Davanti avevamo cartelli con scritto: “Non sparateci, non siamo armati"

Chi innescò il massacro?
Sicuramente non noi, anche se qualcuno disse che furono alcuni bambini a tirare per primi delle pietre.
Noi eravamo disarmati.
La polizia lo sapeva, ma aveva iniziato comunque a tirare lacrimogeni.
Perché alla fine iniziò a sparare?
Perché?
Sicuramente non noi, anche se qualcuno disse che furono alcuni bambini a tirare per primi delle pietre.
Noi eravamo disarmati.
La polizia lo sapeva, ma aveva iniziato comunque a tirare lacrimogeni.
Perché alla fine iniziò a sparare?
Perché?

Non lo so.
Sta di fatto che i poliziotti bianchi iniziarono a sparare senza motivo.
Io non avrei dovuto essere lì.
Non fosse altro per i miei 13 anni.
Mia sorella Antoinette mi vide dall’altro capo della strada e corse verso di me rassicurandomi.
Poi riprese la marcia.
Sta di fatto che i poliziotti bianchi iniziarono a sparare senza motivo.
Io non avrei dovuto essere lì.
Non fosse altro per i miei 13 anni.
Mia sorella Antoinette mi vide dall’altro capo della strada e corse verso di me rassicurandomi.
Poi riprese la marcia.

Io nemmeno mi accorsi di quel poliziotto bianco.
Mentre il corteo cantava "l’inno della liberazione" che il governo aveva assolutamente vietato, il poliziotto bianco aprì il fuoco.
Altri lo seguirono.
E fu l’inferno.
Mentre il corteo cantava "l’inno della liberazione" che il governo aveva assolutamente vietato, il poliziotto bianco aprì il fuoco.
Altri lo seguirono.
E fu l’inferno.
Cosa si prova a ricevere una pallottola in corpo?
Avete presente quando picchiate un gomito contro uno spigolo?
Quella la prima sensazione.
Poi tanto bruciore, si vede tutto nero e si perdono i sensi.
Poi non chiedetemi altro.
So solo che non è stato giusto morire a 13 anni.
Avete presente quando picchiate un gomito contro uno spigolo?
Quella la prima sensazione.
Poi tanto bruciore, si vede tutto nero e si perdono i sensi.
Poi non chiedetemi altro.
So solo che non è stato giusto morire a 13 anni.
Lui, Mbuyisa non aveva partecipato alle proteste, ma quando aveva sentito gli spari era corso per aiutare i feriti.
E’ il ragazzo che mi tiene in braccio nella foto.
Quella che si dispera accanto invece è mia sorella Antoinette.
Mi stanno portando in ospedale.
Inutilmente.

E’ il ragazzo che mi tiene in braccio nella foto.
Quella che si dispera accanto invece è mia sorella Antoinette.
Mi stanno portando in ospedale.
Inutilmente.


Nei giorni successivi ci furono altri scontri.
Il numero delle vittime venne stimato dai 200 a 600.
Secondo il governo sudafricano le vittime furono 23.
Il numero dei feriti fu stimato essere superiore a 1000.
Una commissione d’inchiesta accertò che morirono 575 persone.

Il numero delle vittime venne stimato dai 200 a 600.
Secondo il governo sudafricano le vittime furono 23.
Il numero dei feriti fu stimato essere superiore a 1000.
Una commissione d’inchiesta accertò che morirono 575 persone.


Dicono che una fotografia vale più di mille parole.
Qualcuna, grazie alla sua forza espressiva, è persino riuscita a smuovere le coscienze e messo in atto cambiamenti politici e di costume.
Accadde con quella foto.
La foto con me agonizzante.
Qualcuna, grazie alla sua forza espressiva, è persino riuscita a smuovere le coscienze e messo in atto cambiamenti politici e di costume.
Accadde con quella foto.
La foto con me agonizzante.

A scattare quella foto fu un fotografo sudafricano, Sam Nzima.
Dopo aver ricevuto minacce dalla polizia, si licenziò e scappò da Soweto.
In seguito fu rintracciato, arrestato e costretto agli arresti domiciliari.
Da quel giorno non scattò mai più una foto.
Dopo aver ricevuto minacce dalla polizia, si licenziò e scappò da Soweto.
In seguito fu rintracciato, arrestato e costretto agli arresti domiciliari.
Da quel giorno non scattò mai più una foto.

Sapete, iniziano sempre così.
Con silenziare il dissenso.
Una frase, uno striscione, un canto, una protesta.
Poi cominceranno a togliervi un diritto dopo l’altro.
State attenti.
Se mai dovesse accadere reagite.
Prima che sia troppo tardi.
Con silenziare il dissenso.
Una frase, uno striscione, un canto, una protesta.
Poi cominceranno a togliervi un diritto dopo l’altro.
State attenti.
Se mai dovesse accadere reagite.
Prima che sia troppo tardi.

Mi chiamavo Hector Pieterson e avevo solo 13 anni.
E non sono morto inutilmente.
Dopo quella proteste, iniziate il 16 giugno, il governo sudafricano decise che le scuole potevano usare la lingua di insegnamento che preferivano.
Ricordatevi.
L'indifferenza non paga.
Mai.
E non sono morto inutilmente.
Dopo quella proteste, iniziate il 16 giugno, il governo sudafricano decise che le scuole potevano usare la lingua di insegnamento che preferivano.
Ricordatevi.
L'indifferenza non paga.
Mai.

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh