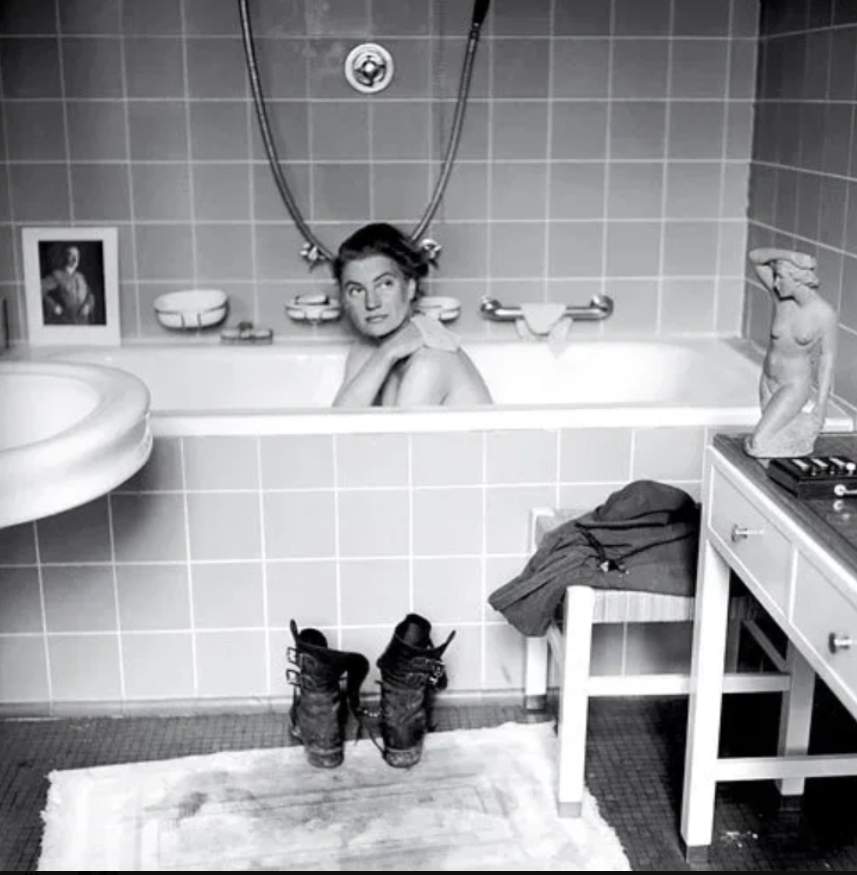Certo che sapevo di poter essere un bersaglio della mafia.
Davanti ai contadini che avevano sfilato per le vie di Corleone gridando “Terra per tutti” c’ero io, malgrado la mia giovane età.
Avevo 34 anni, sindacalista, l’uomo che turbava il sonno al boss Don Michele Navarra.
Davanti ai contadini che avevano sfilato per le vie di Corleone gridando “Terra per tutti” c’ero io, malgrado la mia giovane età.
Avevo 34 anni, sindacalista, l’uomo che turbava il sonno al boss Don Michele Navarra.

Don Michele Navarra, capo di Luciano Liggio.
Una bella coppia.
Nella primavera del 1948 i contadini del feudo Drago, guidati da un giovane sindacalista come me, turbavano il sonno di Navarra e dei suoi scagnozzi.
Gli oppressi si stavano ribellando, finalmente.
Una bella coppia.
Nella primavera del 1948 i contadini del feudo Drago, guidati da un giovane sindacalista come me, turbavano il sonno di Navarra e dei suoi scagnozzi.
Gli oppressi si stavano ribellando, finalmente.
Mi detestava non solo per quello.
Da segretario della locale sezione combattenti e reduci gli avevo rifiutato il titolo di socio onorario.
«Lei non è stato combattente, tanto meno reduce». Un rifiuto che non mi aveva mai perdonato.
Non mi importava, avevo altro a cui pensare.
Da segretario della locale sezione combattenti e reduci gli avevo rifiutato il titolo di socio onorario.
«Lei non è stato combattente, tanto meno reduce». Un rifiuto che non mi aveva mai perdonato.
Non mi importava, avevo altro a cui pensare.
Nato il 2/01/1914 a Corleone, nella II guerra mondiale prestai servizio nel Regio Esercito sui monti della Carnia, in Friuli-Venezia Giulia, con il grado di caporale prima, poi caporal maggiore e infine di sergente.
Dopo l’8 settembre mi unii ai partigiani delle Brigate Garibaldi
Dopo l’8 settembre mi unii ai partigiani delle Brigate Garibaldi
Mi unii al sindacato dei braccianti agricoli nel 1943 e iniziai a organizzare gli agricoltori per migliorare le loro condizioni di lavoro e lottare contro lo sfruttamento. Non solo.
Avevo dato pure manforte a un gruppo di ex partigiani aggrediti da una pattuglia di mafiosi.
Avevo dato pure manforte a un gruppo di ex partigiani aggrediti da una pattuglia di mafiosi.
La mafia non mi intimoriva.
A tal punto che un giorno presi Luciano Liggio per il bavero della giacca e lo appesi a una cancellata con delle punte acuminate.
Dovevate vedere la sua faccia.
Chi è che ha detto pochi giorni fa che con la mafia si deve scendere a compromessi?
A tal punto che un giorno presi Luciano Liggio per il bavero della giacca e lo appesi a una cancellata con delle punte acuminate.
Dovevate vedere la sua faccia.
Chi è che ha detto pochi giorni fa che con la mafia si deve scendere a compromessi?
Placido Rizzotto, questo il suo nome, partigiano e socialista, uscì di casa il 10 marzo 1948.
Erano le 18 e si avviò in direzione di una «trazzera» (strada di campagna per il transito degli animali). L’ultima volta fu visto verso le 22.30 in compagnia di tale Pasquale Criscione.
Erano le 18 e si avviò in direzione di una «trazzera» (strada di campagna per il transito degli animali). L’ultima volta fu visto verso le 22.30 in compagnia di tale Pasquale Criscione.

Uomo appartenente alla famiglia del boss Navarra.
Fu lui ad attirarlo in una trappola.
Da quel momento di lui si perse ogni traccia.
Qualche giorno dopo un giornale di Palermo pubblicò la notizia che un pastore dodicenne era in grado di dare notizie sulla sparizione di Placido.
Fu lui ad attirarlo in una trappola.
Da quel momento di lui si perse ogni traccia.
Qualche giorno dopo un giornale di Palermo pubblicò la notizia che un pastore dodicenne era in grado di dare notizie sulla sparizione di Placido.
Il bambino si chiamava Giuseppe Letizia e si trovava ad accudire il proprio gregge nelle campagne in cui era avvenuto, a parer suo, il delitto.
Aveva visto alcuni uomini uccidere Rizzotto rimanendo sconvolto.
Il padre lo aveva trovato che delirava.
E lo aveva portato in ospedale.
Aveva visto alcuni uomini uccidere Rizzotto rimanendo sconvolto.
Il padre lo aveva trovato che delirava.
E lo aveva portato in ospedale.

Il primario dell’ospedale era proprio lui, il boss Don Michele Navarra.
In preda a febbre alta il pastorello aveva raccontato di aver visto uccidere il Rizzotto.
La sua testimonianza non arrivò mai in tribunale. Dopo un’iniezione praticata dal dottor Ignazio Aira, Giuseppe morì.
In preda a febbre alta il pastorello aveva raccontato di aver visto uccidere il Rizzotto.
La sua testimonianza non arrivò mai in tribunale. Dopo un’iniezione praticata dal dottor Ignazio Aira, Giuseppe morì.
Ufficialmente la morte fu provocata da una tossicosi. Molti i dubbi. Mai fugati.
Il dottore che gli aveva praticato l’iniezione espatriò poco tempo dopo.
Il 26 marzo il quotidiano “La Voce della Sicilia” scrisse che Rizzotto fu caricato su una Fiat 1100, la stessa auto di Liggio.
Il dottore che gli aveva praticato l’iniezione espatriò poco tempo dopo.
Il 26 marzo il quotidiano “La Voce della Sicilia” scrisse che Rizzotto fu caricato su una Fiat 1100, la stessa auto di Liggio.
Furono i carabinieri di Corleone a denunciare Liggio (che nel frattempo era sparito) e tre complici, per sequestro di persona.
Il 30 settembre il giudice istruttore prosciolse Liggio e gli altri.
Al comando di quei carabinieri c’era lui, Carlo Alberto dalla Chiesa
Il 30 settembre il giudice istruttore prosciolse Liggio e gli altri.
Al comando di quei carabinieri c’era lui, Carlo Alberto dalla Chiesa

L’arresto di due mafiosi fu fondamentale.
Rivelarono che era stato Liggio a uccidere Placido per poi gettare il corpo in una voragine.
Grazie a un giornalista, travolto da un treno pochi giorni dopo, il 13 dicembre i carabinieri ritrovarono il luogo dell’omicidio. E la voragine.
Rivelarono che era stato Liggio a uccidere Placido per poi gettare il corpo in una voragine.
Grazie a un giornalista, travolto da un treno pochi giorni dopo, il 13 dicembre i carabinieri ritrovarono il luogo dell’omicidio. E la voragine.
Sul fondo furono ritrovati i resti di tre cadaveri.
Per esplorare a fondo la grotta sarebbe stata necessaria una spesa di un milione e mezzo, ma la Corte d’Assise di Palermo non ritenne necessaria tale spesa.
E data la mancanza della prova certa assolse tutti, Liggio compreso.
Per esplorare a fondo la grotta sarebbe stata necessaria una spesa di un milione e mezzo, ma la Corte d’Assise di Palermo non ritenne necessaria tale spesa.
E data la mancanza della prova certa assolse tutti, Liggio compreso.

Nel 2009, in quella voragine di Rocca Busambra a Corleone, furono ritrovati resti umani.
Nel 2012 l’esame del DNA, comparato con quello estratto dal padre di Placido, Carmelo Rizzotto, morto da tempo, confermerà l’appartenenza al sindacalista siciliano dei resti rinvenuti.
Nel 2012 l’esame del DNA, comparato con quello estratto dal padre di Placido, Carmelo Rizzotto, morto da tempo, confermerà l’appartenenza al sindacalista siciliano dei resti rinvenuti.

Nella foiba, profonda 50 metri, furono trovati altri resti umani e i resti del mulo usato per trasferire il cadavere di Placido.
Sono stati ritrovati anche dei filamenti di cuoio (forse le redini del mulo) e una moneta da 10 centesimi coniata negli anni ‘20
Sono stati ritrovati anche dei filamenti di cuoio (forse le redini del mulo) e una moneta da 10 centesimi coniata negli anni ‘20

"Nel 1948, Rizzotto venne ucciso dalla mafia siciliana per il suo impegno sindacale. Il suo assassinio fu un evento significativo e scosse profondamente l'opinione pubblica italiana, contribuendo a sollevare l'attenzione sulla presenza e l'influenza della mafia nell'isola". 

In quegli anni furono uccisi, solo in Sicilia, ben 47 capi del movimento contadino.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il 24 maggio 2012 a Corleone (PA), si sono volti solenni funerali di Stato per Placido Rizzotto


Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il 24 maggio 2012 a Corleone (PA), si sono volti solenni funerali di Stato per Placido Rizzotto


Dopo la morte di Rizzotto il suo posto fu preso dal politico comunista Pio La Torre che Dalla Chiesa conobbe proprio in quella occasione.
Pio La Torre verrà ucciso dalla mafia il 30 aprile 1982. Carlo Alberto dalla Chiesa verrà ucciso il 3 settembre dello stesso anno.


Pio La Torre verrà ucciso dalla mafia il 30 aprile 1982. Carlo Alberto dalla Chiesa verrà ucciso il 3 settembre dello stesso anno.


“Non si nasce schiavi o padroni; chi ci vuole diventare ci diventa. Noi dobbiamo restare uniti, compagni, perché da soli non si cambiano le cose.
Perché da soli non si cambiano le cose”.
(Placido Rizzotto)
Perché da soli non si cambiano le cose”.
(Placido Rizzotto)

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh

 Read on Twitter
Read on Twitter