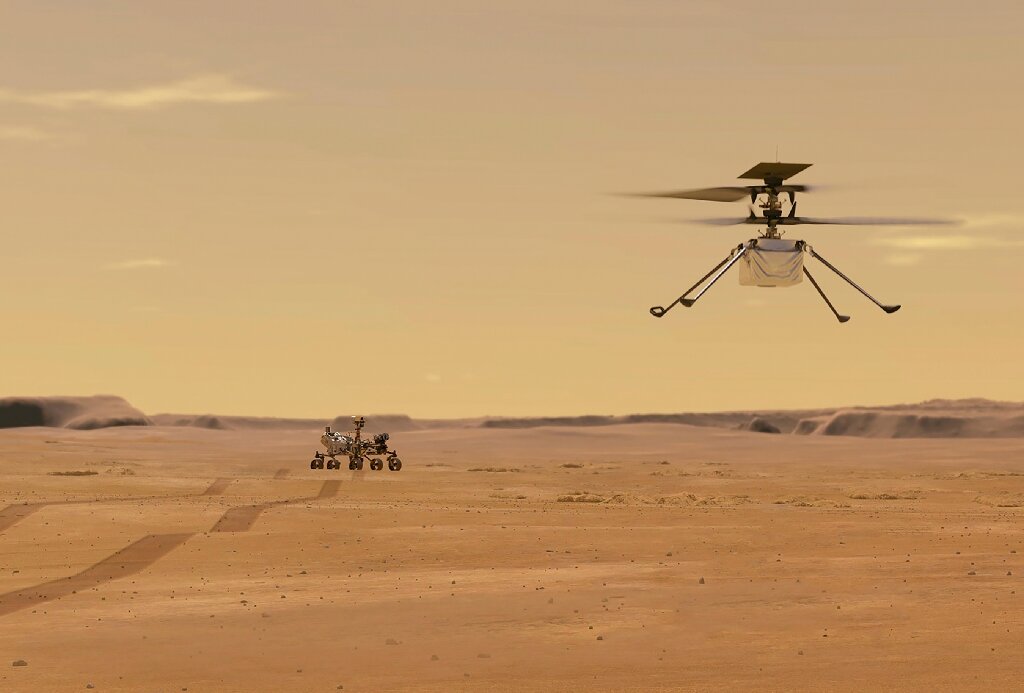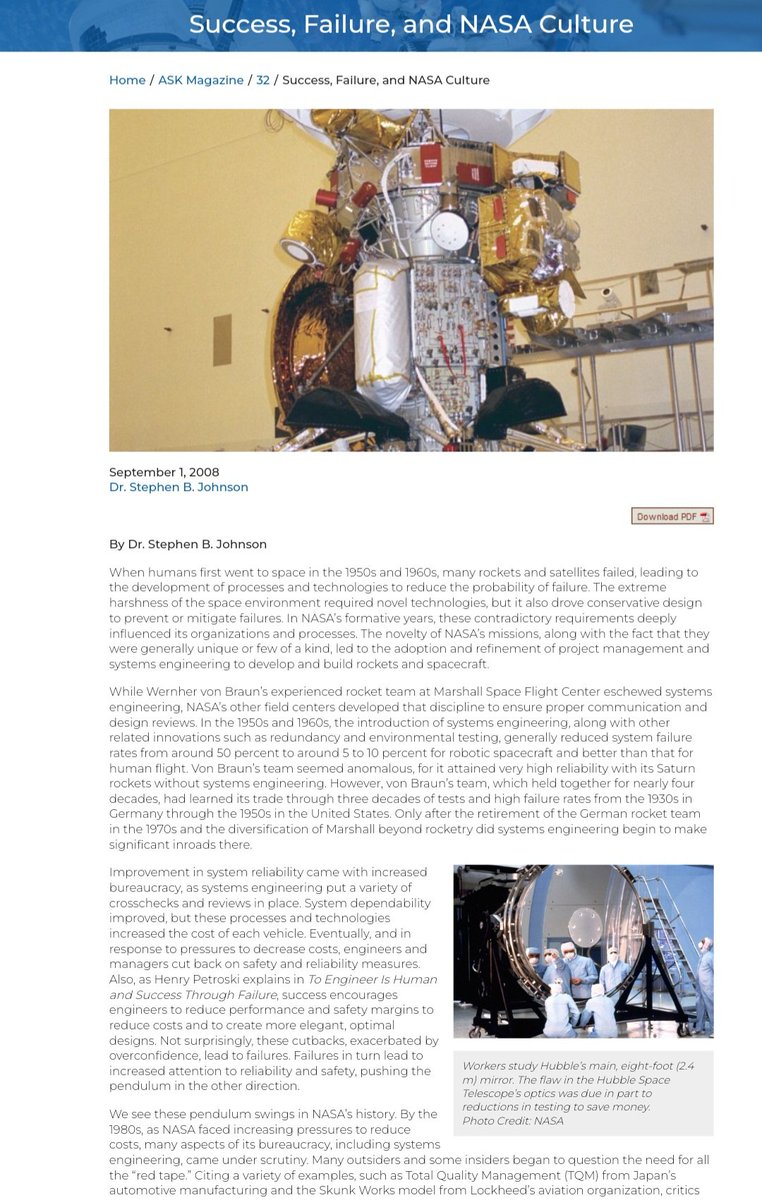I satelliti SOHO, DISCOVR, Gaia, James Webb e Euclid hanno qualcosa in comune tra loro e con i protagonisti di molte storie di fantascienza: ognuno di loro si trova in un "punto lagrangiano". Di che si tratta?
(continua)
(continua)

I punti lagrangiani o punti di librazione sono punti nei quali un oggetto relativamente piccolo soggetto all’influenza gravitazionale di due corpi più grandi rimane in una posizione fissa rispetto a essi, perché le varie forze a cui è soggetto si equilibrano. 

Sono cinque e prendono il nome dal matematico torinese Joseph-Louis Lagrange (nato Giuseppe Luigi Lagrangia), anche se i primi tre furono scoperti prima di lui da Leonhard Euler.




Ogni coppia di corpi celesti ha i suoi punti lagrangiani: per esempio, il sistema Terra-Sole ne ha 5 e il sistema Terra-Luna ne ha altri 5. Sono particolarmente adatti per ospitare sonde spaziali, perché è possibile tenerle in quella posizione con poche correzioni orbitali. 

Di questi cinque punti, il più facile da comprendere intuitivamente è L1. Prendiamo il sistema Terra-Sole e partiamo dal fatto che più un pianeta è vicino al Sole, più gli gira intorno velocemente, altrimenti verrebbe catturato dalla sua attrazione gravitazionale.
Per esempio Mercurio fa una rivoluzione completa intorno al Sole in appena 88 giorni, contro i 365 della Terra, che è più lontana. 

Ma se un satellite si trova tra la Terra e il Sole ed è abbastanza vicino alla Terra, l’attrazione gravitazionale del nostro pianeta cancella parte di quella del Sole e gli permette di muoversi intorno al Sole più lentamente senza essere catturato.
Se il satellite si trova nella posizione giusta, a circa un centesimo della distanza tra la Terra e il Sole, girerà intorno al Sole esattamente nello stesso tempo che impiega la Terra e quindi si troverà sempre nella stessa posizione rispetto al nostro pianeta. 

Questo è il punto L1. È un punto ideale per osservare il sistema Terra-Sole, dato che in quella posizione non è mai eclissato dalla Terra o dalla Luna. Qui si trovano tra gli altri l’osservatorio solare SOHO e il satellite di osservazione terrestre DSCOVR. 

Il punto L2 si trova alla stessa distanza di un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, ma dalla parte opposta rispetto al Sole. Questo invece è un punto ideale per osservare lo spazio: è abbastanza lontano dalla Terra per uscire dal suo cono d’ombra. 

Questo consente di alimentare i pannelli solari, ma la sua posizione permette di bloccare con un unico schermo il calore proveniente dal Sole, dalla Terra e dalla Luna e quindi di mantenere facilmente le temperature molto basse richieste dagli strumenti scientifici. 

Si trovano qui, tra l'altro, GAIA, James Webb e Euclid. Non c’è pericolo che si scontrino fra di loro in quanto le aree intorno al vero e proprio punto lagrangiano in cui i satelliti possono rimanere consumando poco propellente hanno un’ampiezza dell’ordine di 800 000 chilometri. 

L3 si trova sulla stessa retta di L1 e L2, ma dalla parte opposta rispetto al Sole: si muove cioè sull’orbita terrestre rimanendo sempre a 180 gradi rispetto a noi (e quindi non è mai visibile dalla Terra perché nascosto dal Sole). 

Qui alcuni filosofi greci antichi e molti racconti di fantascienza hanno collocato una “AntiTerra” popolata da esseri più o meno simili a noi. 

Non ci sono invece mai state sonde spaziali, anche se un satellite in L3 sarebbe in grado di monitorare da vicino l'evoluzione delle macchie solari prima che abbiano effetto sulla Terra, permettendo così di mandare preavvisi con un anticipo di 7 giorni. 

L4 e L5 sono anch’essi sull’orbita terrestre, ai vertici di due triangoli equilateri formati anche dalla Terra e dal Sole. Non hanno un particolare interesse per le sonde spaziali, ma hanno la caratteristica di essere punti di equilibrio stabile, 

mentre in L1 e L2 e L3 l'equilibrio è instabile, cosa che richiede periodiche correzioni di rotta ai satelliti che li abitano (e rende impossibile l’esistenza dell’AntiTerra).
Per questo, come aveva previsto Lagrange, molti pianeti hanno nei punti L4 e L5 degli asteroidi “troiani” (i primi sono stati chiamati Achille, Ettore e Patroclo): Giove probabilmente ne ha oltre un milione. Anche la Terra ha almeno due asteroidi in L4: 2010 TK7 e 2020 XL5.
Ci sono punti lagrangiani anche nel sistema Terra-Luna, sebbene disturbati dall’influenza del Sole. Nel punto L2 del sistema Terra-Luna la Cina ha posizionato nel 2018 un satellite-relé per comunicare con il suo lander atterrato sulla faccia nascosta del nostro satellite. 

I punti L4 e L5 del sistema Terra-Luna sono invece stati proposti nel 1975 dal fisico Gerald K. O’Neill come sedi di future colonie spaziali terrestri.
E gli extraterrestri?
E gli extraterrestri?

La NASA osserva che, siccome L3 ha un equilibrio instabile su scale di tempo dell’ordine dei secoli, non può ospitare un pianeta gemello del nostro, ma sarebbe perfetto per parcheggiare per un po’ una forza aliena di invasione della Terra. Meglio stare in guardia…
(fine)
(fine)

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh

 Read on Twitter
Read on Twitter