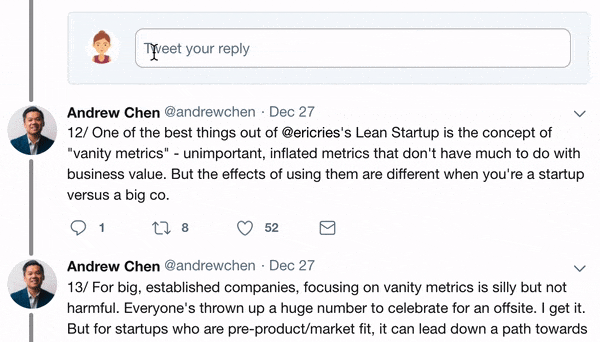Non sei obbligato ad ascoltare la storia della mia vita Johannes. So che ti costa fatica e so quello che provi ogni volta che leggi queste storie.
Sai già che la mia è una di quelle che tocca nel profondo.
Se non vuoi ascoltarla ti basta un click.
E io me ne vado.
Sai già che la mia è una di quelle che tocca nel profondo.
Se non vuoi ascoltarla ti basta un click.
E io me ne vado.
Vedo che sei ancora qui.
Quindi mi sento autorizzato a raccontare quello che è accaduto in quei giorni.
Di come tutto possa precipitare da un momento all’altro quando meno te lo aspetti.
La mia infanzia? Come quella di tanti altri.
Quindi mi sento autorizzato a raccontare quello che è accaduto in quei giorni.
Di come tutto possa precipitare da un momento all’altro quando meno te lo aspetti.
La mia infanzia? Come quella di tanti altri.
Sono nato a Caposele, in provincia di Avellino al confine con quella di Salerno, il 29 gennaio 1927.
Una splendida terra la mia. E molto generosa.
Tanto da regalare la sua principale ricchezza ai pugliesi. Le sorgenti di Santa Maria della Sanità e del fiume Sele.
Una splendida terra la mia. E molto generosa.
Tanto da regalare la sua principale ricchezza ai pugliesi. Le sorgenti di Santa Maria della Sanità e del fiume Sele.
Lo sai Johannes che gli antichi attribuivano al fiume Sele una proprietà magica?
Qualunque oggetto di legno immerso nelle sue acque per un certo periodo di tempo diventa pietra.
Non ci credi?
Lo ha scritto Aristotele, il sommo filosofo greco.
Lui il fiume lo chiamava Ceto.
Qualunque oggetto di legno immerso nelle sue acque per un certo periodo di tempo diventa pietra.
Non ci credi?
Lo ha scritto Aristotele, il sommo filosofo greco.
Lui il fiume lo chiamava Ceto.
E pure il geografo Strabone ne parla.
“I virgulti immersi nelle sue acque sassificano pur conservando la forma e il colore primitivo“.
E poi Plinio.
“Similmente nel fiume Sele oltre Salerno, si trasformano in pietra non solo i rami che vi si immergono, ma anche le foglie“.
“I virgulti immersi nelle sue acque sassificano pur conservando la forma e il colore primitivo“.
E poi Plinio.
“Similmente nel fiume Sele oltre Salerno, si trasformano in pietra non solo i rami che vi si immergono, ma anche le foglie“.
Non sto cambiando discorso Johannes.
Comunque puoi chiamarmi Leuccio, come hanno sempre fatto tutti in paese.
Ho una moglie, Raffaella, che in paese chiamano Faluccia, e tre figli, Carmela, Enzo e Alfonsina.
Dei figli bellissimi.
E io con il lavoro più bello del mondo.
Comunque puoi chiamarmi Leuccio, come hanno sempre fatto tutti in paese.
Ho una moglie, Raffaella, che in paese chiamano Faluccia, e tre figli, Carmela, Enzo e Alfonsina.
Dei figli bellissimi.
E io con il lavoro più bello del mondo.
Almeno per me.
Custode e addetto alla manutenzione nella parte iniziale della più grande opera idraulica.
La galleria Pavoncelli lunga 260 km, che porta oltre 4.000 litri al secondo fino in Puglia.
Si chiama Acquedotto Pugliese, anche se parte in Irpinia.
Custode e addetto alla manutenzione nella parte iniziale della più grande opera idraulica.
La galleria Pavoncelli lunga 260 km, che porta oltre 4.000 litri al secondo fino in Puglia.
Si chiama Acquedotto Pugliese, anche se parte in Irpinia.
Te l’ho detto, siamo generosi.
La Puglia era sempre stata povera di acqua.
Orazio la descriveva come terra assetata: "siderum insedit vapor siticulosae Apuliae" (arriva alle stelle l'afa della Puglia sitibonda).
Loro senza acqua.
E noi invece, a Caposele, ne avevamo tanta.
La Puglia era sempre stata povera di acqua.
Orazio la descriveva come terra assetata: "siderum insedit vapor siticulosae Apuliae" (arriva alle stelle l'afa della Puglia sitibonda).
Loro senza acqua.
E noi invece, a Caposele, ne avevamo tanta.
Così all’inizio del secolo si era cominciato a costruire l'acquedotto.
Per me un onore lavorarci.
La nostra casa era la foresteria all'imbocco della galleria Pavoncelli. Una vita tranquilla.
I figli che crescono, una bella moglie. Normalità.
Fino a quel maledetto giorno.
Per me un onore lavorarci.
La nostra casa era la foresteria all'imbocco della galleria Pavoncelli. Una vita tranquilla.
I figli che crescono, una bella moglie. Normalità.
Fino a quel maledetto giorno.

Forse avrei dovuto immergere il mio corpo nelle acque del Sele.
Sarei diventato più forte e forse sarei riuscito a resistere a quella tempesta.
Sicuramente avrei dovuto farlo almeno con i miei figli. Per renderli resistenti come pietre.
Sarei diventato più forte e forse sarei riuscito a resistere a quella tempesta.
Sicuramente avrei dovuto farlo almeno con i miei figli. Per renderli resistenti come pietre.
Ricordo benissimo quel giorno.
Il giorno precedente, un sabato, avevamo festeggiato il compleanno di mia figlia Carmela, la primogenita.
Mia moglie Faluccia aveva preparato una bella torta. Una bellissima giornata. Mai immaginando.
Il giorno precedente, un sabato, avevamo festeggiato il compleanno di mia figlia Carmela, la primogenita.
Mia moglie Faluccia aveva preparato una bella torta. Una bellissima giornata. Mai immaginando.
Il giorno dopo, domenica 23 novembre 1980, a mezzogiorno, ricevemmo una telefonata da mio cognato.
Voleva parlare con mio figlio Enzo.
Lo invitava a casa sua a Lioni, in provincia di Avellino.
Voleva parlare con mio figlio Enzo.
Lo invitava a casa sua a Lioni, in provincia di Avellino.
Enzo era entusiasta.
E così era andato lo avevamo accompagnato.
Non ricordo altro.
Ricordo solo che alle 19 Carmela prese l’auto e con Alfonsina andò a riprendere Enzo per riportarlo a casa.
E così era andato lo avevamo accompagnato.
Non ricordo altro.
Ricordo solo che alle 19 Carmela prese l’auto e con Alfonsina andò a riprendere Enzo per riportarlo a casa.
Erano le 19.34 quando iniziò a tremare tutto.
Novanta lunghissimi secondi.
La nostra casa subì numerosi danni, ma non crollò. Questo permise a me e a mia moglie di fuggire in strada.
Erano quasi le 20, quando la vidi.

Novanta lunghissimi secondi.
La nostra casa subì numerosi danni, ma non crollò. Questo permise a me e a mia moglie di fuggire in strada.
Erano quasi le 20, quando la vidi.


La sezione iniziale dell’acquedotto, intendo.
Era danneggiata. C’era il rischio di dover bloccare l’erogazione dell’acqua verso la Puglia.
Ero preoccupato, angosciato per i miei figli, cognato, cognata, nipotini.
Non avevo notizie, ma dovevo agire. Subito.
Era danneggiata. C’era il rischio di dover bloccare l’erogazione dell’acqua verso la Puglia.
Ero preoccupato, angosciato per i miei figli, cognato, cognata, nipotini.
Non avevo notizie, ma dovevo agire. Subito.

Con altri colleghi rimanemmo all’acquedotto per eseguire tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza il tutto. Senza dormire.
Mangiando pochissimo.
Un lavoro estenuante, ti garantisco.
Ma necessario.
Mangiando pochissimo.
Un lavoro estenuante, ti garantisco.
Ma necessario.
Fu solo mercoledì 26 novembre che ricevetti la notizia. Avevano ritrovato Carmela, Enzo e Alfonsina.
E anche mio cognato, mia cognata e i nipotini.
Sotto le macerie.
La casa dove si trovavano in quel momento era crollata su di loro.
E anche mio cognato, mia cognata e i nipotini.
Sotto le macerie.
La casa dove si trovavano in quel momento era crollata su di loro.

Carmela, aveva 22 anni. Enzo di anni ne aveva 18.
E Alfonsina 15. Tutti morti. I miei angeli.
Che strazio Johannes. E poi tutte quelle telefonate.
I parenti che stavano a Milano che ci invitavano a salire da loro. Ma io non potevo partire.


E Alfonsina 15. Tutti morti. I miei angeli.
Che strazio Johannes. E poi tutte quelle telefonate.
I parenti che stavano a Milano che ci invitavano a salire da loro. Ma io non potevo partire.



I lavori all’acquedotto non erano conclusi.
Tutta l’acqua della Puglia dipendeva da mio lavoro e da quello dei miei colleghi.
Continuai, con la morte nel cuore, ad andare sul posto di lavoro.
Per sei lunghissimi e strazianti giorni.
Tutta l’acqua della Puglia dipendeva da mio lavoro e da quello dei miei colleghi.
Continuai, con la morte nel cuore, ad andare sul posto di lavoro.
Per sei lunghissimi e strazianti giorni.
E qui finisce la storia raccontata in prima persona da Leone Cuozzo, che tutti chiamavano Leuccio.
Seppur in un mutismo straziante, mise in sicurezza l’Acquedotto Pugliese, perché diceva: “milioni di persone dipendono da me”.
Per sei lunghissimi giorni
Seppur in un mutismo straziante, mise in sicurezza l’Acquedotto Pugliese, perché diceva: “milioni di persone dipendono da me”.
Per sei lunghissimi giorni
Poi, sabato 29 novembre, salì in macchina con la moglie intenzionato ad andare a Roma.
Con una scusa scese dall’auto e risalì in casa, richiudendo la porta dietro di sé.
Un colpo di fucile fu l’ultima scelta della sua vita.
Con una scusa scese dall’auto e risalì in casa, richiudendo la porta dietro di sé.
Un colpo di fucile fu l’ultima scelta della sua vita.

Il 6 luglio del 2012, alla presenza della moglie Raffaella, è stato dedicato a Leone Cuozzo il nuovo potabilizzatore dell’Acquedotto Pugliese che consente di immettere nella rete l’acqua raccolta dall’invaso artificiale di Conza della Campania. 

Quei 90 interminabili secondi del 23 novembre 1980 distrussero gran parte dell’Irpinia e della Basilicata provocando 2.914 morti, 8.848 feriti e circa 280.000 sfollati.
Che se ci guardi dentro, non sono soltanto numeri.
Che se ci guardi dentro, non sono soltanto numeri.
L’acquedotto Pugliese è un’opera straordinaria.
Oggi è l’acquedotto più lungo d’Europa e il terzo al mondo.
40.000 chilometri di reti, 5 potabilizzatori, 184 impianti di depurazione.
Con un telecontrollo di 4500 sensori e 1250 postazioni, serve oltre quattro milioni di persone
Oggi è l’acquedotto più lungo d’Europa e il terzo al mondo.
40.000 chilometri di reti, 5 potabilizzatori, 184 impianti di depurazione.
Con un telecontrollo di 4500 sensori e 1250 postazioni, serve oltre quattro milioni di persone

E questa è la storia di Leone Cuozzo, detto Leuccio.
La storia di un uomo che mentre crollava tutto, intorno a lui e dentro di lui, si preoccupò di garantire acqua a milioni di pugliesi.
Perché quello, diceva, era il suo lavoro.
La storia di un uomo che mentre crollava tutto, intorno a lui e dentro di lui, si preoccupò di garantire acqua a milioni di pugliesi.
Perché quello, diceva, era il suo lavoro.

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh