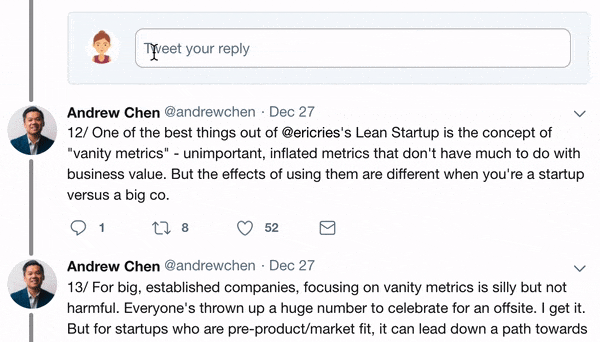Mamma si chiamava Franzisca Grünwald, una bella infermiera di ventisei anni.
Papà un ufficiale medico di trentatré anni di nome Albert Salomon.
Il luogo? Un ospedale di fortuna sul fronte di guerra in Francia.
Come riuscì a conquistarlo?
Fu grazie a uno starnuto.
Papà un ufficiale medico di trentatré anni di nome Albert Salomon.
Il luogo? Un ospedale di fortuna sul fronte di guerra in Francia.
Come riuscì a conquistarlo?
Fu grazie a uno starnuto.
Quel giorno Albert stava operando un soldato, le mani occupate, poi uno starnuto e il naso che cola.
Fu mamma, la bella infermiera, a estrarre il suo fazzoletto per pulirgli il naso.
E fu in quel preciso momento che lui si accorse di lei. E se ne innamorò.
Fu mamma, la bella infermiera, a estrarre il suo fazzoletto per pulirgli il naso.
E fu in quel preciso momento che lui si accorse di lei. E se ne innamorò.
Un breve fidanzamento e nel 1916 il matrimonio a Berlino.
Una cerimonia religiosa ebraica e poi il ritorno al fronte per lui. Per lei una casa vuota.
Papà tornò dal fronte giusto in tempo per vedermi nascere. Era il 16 aprile 1917.
Una cerimonia religiosa ebraica e poi il ritorno al fronte per lui. Per lei una casa vuota.
Papà tornò dal fronte giusto in tempo per vedermi nascere. Era il 16 aprile 1917.
Alla mia nascita il primo e unico motivo di attrito tra mamma e papà.
Lei voleva chiamarmi Charlotte, come sua sorella morta a diciotto anni.
Papà non voleva dare il nome di una defunta a sua figlia. Mamma fu irremovibile.
Per questo mi chiamo Charlotte, come sua sorella.
Lei voleva chiamarmi Charlotte, come sua sorella morta a diciotto anni.
Papà non voleva dare il nome di una defunta a sua figlia. Mamma fu irremovibile.
Per questo mi chiamo Charlotte, come sua sorella.
Charlotte era morta annegata. Mai capito. Perché era entrata in acqua se non sapeva nuotare? Mamma lo diceva sempre. Perché non esiste nel dizionario una parola per definire la perdita di una sorella? Mamma era sempre triste. La chiamano una vita a due, ma papà era sempre lontano
I miei primi ricordi? Le note suonate dalla mamma al pianoforte.Quel canto angelico, come una carezza.
Ma sempre triste. Quelle lacrime per la perdita della sorella. Comunque una vita agiata. Le passeggiate per le strade di Berlino.
E le mani tese dei mendicanti. Tante, troppe.
Ma sempre triste. Quelle lacrime per la perdita della sorella. Comunque una vita agiata. Le passeggiate per le strade di Berlino.
E le mani tese dei mendicanti. Tante, troppe.
Avevo otto anni quando mamma ingerì una boccetta di oppio. Non morì, ma papà volle trasferirsi dai nonni. Con un’infermiera per la mamma.
Lei mi aveva avvisata: "presto andrò in cielo, mi trasformerò in un angelo e ti scriverò una lettera per raccontarti come vanno le cose lassù"
Lei mi aveva avvisata: "presto andrò in cielo, mi trasformerò in un angelo e ti scriverò una lettera per raccontarti come vanno le cose lassù"
Avevo nove anni quando andò davvero in cielo.
Mio padre mi disse che la mamma se l’era portata via un’influenza fulminante. Povera mamma.
Dopo la sua morte papà decise di traslocare.
Troppi ricordi in quella casa. Mi rifiutai.
Mio padre mi disse che la mamma se l’era portata via un’influenza fulminante. Povera mamma.
Dopo la sua morte papà decise di traslocare.
Troppi ricordi in quella casa. Mi rifiutai.

“Non possiamo”, gli dissi, “il postino non ci troverebbe e io aspetto la lettera che la mamma mi ha promesso dal cielo”.
Papà allora si tuffò nel lavoro e ritenne giusto mandarmi a vivere coi nonni.
Nella stessa stanza di mamma quando era bambina.
Papà allora si tuffò nel lavoro e ritenne giusto mandarmi a vivere coi nonni.
Nella stessa stanza di mamma quando era bambina.
Non fu una bella idea.
La nonna soprapponeva presente a passato.
Due figlie morte. Troppo per una madre.
E poi il primo Natale senza la mamma.
Triste, vuoto, silenzioso.
Con mamma era vivace, luminoso.
Passava ore a suonare canti di Natale.
La nonna soprapponeva presente a passato.
Due figlie morte. Troppo per una madre.
E poi il primo Natale senza la mamma.
Triste, vuoto, silenzioso.
Con mamma era vivace, luminoso.
Passava ore a suonare canti di Natale.
Avevo 13 anni quando papà Albert conobbe Paula, una cantante lirica.
Volle il mio assenso per il matrimonio.
In sinagoga perché Paula era figlia di un rabbino.
Per me e papà invece la religione ebraica aveva un ruolo marginale.
Direi nullo. Conducevamo una vita laica.
Volle il mio assenso per il matrimonio.
In sinagoga perché Paula era figlia di un rabbino.
Per me e papà invece la religione ebraica aveva un ruolo marginale.
Direi nullo. Conducevamo una vita laica.

Quando Paula venne ad abitare da noi, al 15 di Wielandstrasse, tutto cambiò. Niente più silenzi nella casa. Molte feste. Paula aprì le porte a personaggi famosi. Albert Einstein, l’architetto Erich Mendelsohn e Albert Schweitzer. L’apoteosi tedesca. Mentre si cantava e si ballava
Passavo molto tempo con i nonni. Soprattutto con la nonna, sempre triste per aver perso due figlie.
Prima Charlotte poi mamma Franziska. L’unico mio svago? Andare a teatro a sentire Paula, la mia matrigna, cantare. Sempre ovazioni alla fine. Applausi a non finire. Non durò molto
Prima Charlotte poi mamma Franziska. L’unico mio svago? Andare a teatro a sentire Paula, la mia matrigna, cantare. Sempre ovazioni alla fine. Applausi a non finire. Non durò molto
Avevo quasi sedici anni quel gennaio del 1933, quando l’odio in Germania salì al potere.
E per noi ebrei tutto cambiò.
Basta spettacoli per Paula.
Basta carriera per papà Albert.
I libri cominciarono a bruciare.
E per noi ebrei tutto cambiò.
Basta spettacoli per Paula.
Basta carriera per papà Albert.
I libri cominciarono a bruciare.
Paula avrebbe potuto andare negli Stati Uniti a cantare.
E papà Albert avrebbe potuto continuare la sua professione vicino a lei.
Rifiutò.
“Il mio Paese è la Germania, Bisogna essere ottimisti e convincersi che prima o poi l’odio passerà”.
E papà Albert avrebbe potuto continuare la sua professione vicino a lei.
Rifiutò.
“Il mio Paese è la Germania, Bisogna essere ottimisti e convincersi che prima o poi l’odio passerà”.
Non passò, anzi. Noi ebrei fummo messi al bando.
Ero terrorizzata. Dicevano che avevo il sangue cattivo. Papà cercò invano di rassicurarmi.
Finii per chiudermi in me stessa. Fu allora che mi avvicinai al disegno. Impazzii di gioia quando i nonni mi portarono a visitare l’Italia.
Ero terrorizzata. Dicevano che avevo il sangue cattivo. Papà cercò invano di rassicurarmi.
Finii per chiudermi in me stessa. Fu allora che mi avvicinai al disegno. Impazzii di gioia quando i nonni mi portarono a visitare l’Italia.
Scoprii nuovi orizzonti. Tutta quella cultura, quella civiltà antica. Quella pittura. Visitammo decine di musei. Fu straziante lasciare tutta quella bellezza per tornare in Germania.
Fu allora che decisi che sarei diventata una pittrice. Papà mi regalò delle lezioni private.
Fu allora che decisi che sarei diventata una pittrice. Papà mi regalò delle lezioni private.

Nell’inverno tra il 1937 e il 1938 abbandonai l’Accademia di Belle Arti di Berlino.
Ero entrata grazie al professor Bartning anche se il leader di un movimento studentesco aveva contestato la mia ammissione perché ero “un pericolo per l’integrità sessuale dei maschi ariani”.
Ero entrata grazie al professor Bartning anche se il leader di un movimento studentesco aveva contestato la mia ammissione perché ero “un pericolo per l’integrità sessuale dei maschi ariani”.

Poi tutto precipitò.
Quando nel 1938 esplose la Notte dei cristalli.
Quando distrussero le sinagoghe e le case di preghiera ebraiche.
E poi negozi, cimiteri e case private.
Decine di ebrei assassinati. Odio, solo odio.
Quando nel 1938 esplose la Notte dei cristalli.
Quando distrussero le sinagoghe e le case di preghiera ebraiche.
E poi negozi, cimiteri e case private.
Decine di ebrei assassinati. Odio, solo odio.

Papà venne arrestato e deportato nel campo di concentramento di Sachsenhausen.
Volevano che fuggissi.
Anche se mi avevano chiamata «piccola bestia ebrea» restai, continuando a dipingere
E poi arrivò quel maledetto 5 marzo del 1940.
Quando nonna si tolse la vita.
Volevano che fuggissi.
Anche se mi avevano chiamata «piccola bestia ebrea» restai, continuando a dipingere
E poi arrivò quel maledetto 5 marzo del 1940.
Quando nonna si tolse la vita.

Fu la pazzia di nonno che rivelarmi la verità.
Si scagliò contro di me con la vera storia della nostra famiglia.
Charlotte non era annegata perché non sapeva nuotare. Charlotte si era gettata volontariamente da un ponte per morire.
E anche mamma non era morta per un’influenza.
Si scagliò contro di me con la vera storia della nostra famiglia.
Charlotte non era annegata perché non sapeva nuotare. Charlotte si era gettata volontariamente da un ponte per morire.
E anche mamma non era morta per un’influenza.

Mamma prima di andare in cielo aveva aperto la finestra e si era buttata.
Misi tutto il mio dolore nel diario.
Ero in Costa Azzurra quando arrivò la Gestapo.
Nel frattempo avevo conosciuto un rifugiato austriaco ebreo, Alexander Nagler, lo avevo sposato ed ero rimasta incinta.
Misi tutto il mio dolore nel diario.
Ero in Costa Azzurra quando arrivò la Gestapo.
Nel frattempo avevo conosciuto un rifugiato austriaco ebreo, Alexander Nagler, lo avevo sposato ed ero rimasta incinta.
Fu il farmacista a fare la spia.
Il 21 settembre fummo arrestati.
Sei giorni dopo trasportati nel campo di transito di Drancy, vicino a Parigi.
Il 7 ottobre sul convoglio numero 60 diretto ad Auschwitz.
In un attimo passai dal camino con il mio piccolo in grembo.
Il 21 settembre fummo arrestati.
Sei giorni dopo trasportati nel campo di transito di Drancy, vicino a Parigi.
Il 7 ottobre sul convoglio numero 60 diretto ad Auschwitz.
In un attimo passai dal camino con il mio piccolo in grembo.
Tutti conoscono “Il diario di Anna Frank”.
Pochi conoscono il “diario” di Charlotte Salomon, “Vita? O Teatro?”.
Un misto di pittura e testi in 1325 fogli, realizzati tra il 1940 e il 1942, dove racconta l'infanzia, gli studi, il suicidio della madre, la fuga dal nazismo.

Pochi conoscono il “diario” di Charlotte Salomon, “Vita? O Teatro?”.
Un misto di pittura e testi in 1325 fogli, realizzati tra il 1940 e il 1942, dove racconta l'infanzia, gli studi, il suicidio della madre, la fuga dal nazismo.


Molti ebrei riuscirono a fuggire dalla Germania.
Molti rimasero ritenendo quel periodo un momento passeggero, dovuto alla crisi.
Non andò così, perché quando l’odio sale al potere niente può fermare la bestia dell’intolleranza.

Molti rimasero ritenendo quel periodo un momento passeggero, dovuto alla crisi.
Non andò così, perché quando l’odio sale al potere niente può fermare la bestia dell’intolleranza.


• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh