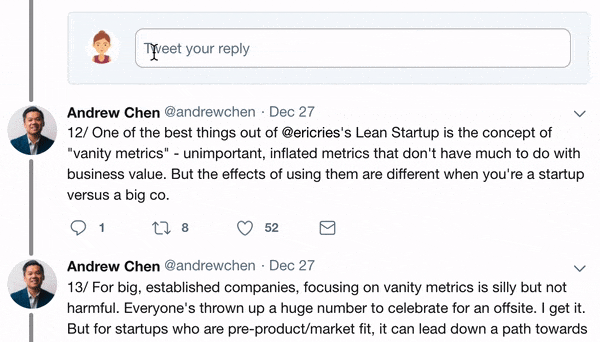Non hanno tutti i torti a chiamarmi “Mago Bakù”, il fachiro.
Mangio pochissimo, dormo quasi niente, giro sempre seminudo e a piedi scalzi.
E non sono le uniche stranezze.
Colleziono anche libri antichi, amo la psicologia, la magia, l’ipnosi e le teorie di Freud.
Mangio pochissimo, dormo quasi niente, giro sempre seminudo e a piedi scalzi.
E non sono le uniche stranezze.
Colleziono anche libri antichi, amo la psicologia, la magia, l’ipnosi e le teorie di Freud.
I miei uomini lo sanno.
Finché sono sveglio non hanno niente da temere.
Per questo, come vi ho detto, dormo pochissimo.
Chi sono?
Sono il comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina Italiana.
E oggi, 16 ottobre 1940, ho un problema.
Finché sono sveglio non hanno niente da temere.
Per questo, come vi ho detto, dormo pochissimo.
Chi sono?
Sono il comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina Italiana.
E oggi, 16 ottobre 1940, ho un problema.

Ieri alle 23.15 abbiamo incrociato a 800 miglia ad ovest di Casablanca il piroscafo Kabalo da 7.500 tonnellate, battente bandiera belga.
Lo so, non siamo in guerra con il Belgio, ma sappiamo che è stato noleggiato dalla marina inglese e armato con un cannone da 102 mm.
Lo so, non siamo in guerra con il Belgio, ma sappiamo che è stato noleggiato dalla marina inglese e armato con un cannone da 102 mm.
Trasportava parti di aerei e armamenti vari, aggregato ad un convoglio diretto in America.
Ma ad un certo punto si era sganciato per dirigersi alla base inglese di Freetown.
Perché ho detto “trasportava”?
Non so come dirvelo.
L’ho appena affondato.
Ma ad un certo punto si era sganciato per dirigersi alla base inglese di Freetown.
Perché ho detto “trasportava”?
Non so come dirvelo.
L’ho appena affondato.
L'avevo inseguito, appena avvistato, per attaccarlo a cannonate.
E' la mia caratteristica quella di attaccare in superficie.
Per combattere ad armi pari con il nemico? Anche.
Ma principalmente perché i siluri sono quello che sono.
Un sicuro fallimento.
E' la mia caratteristica quella di attaccare in superficie.
Per combattere ad armi pari con il nemico? Anche.
Ma principalmente perché i siluri sono quello che sono.
Un sicuro fallimento.

Sono bastate una dozzina di cannonate per indurre il capitano Vogels a dare l’ordine ai suoi uomini di abbandonare il piroscafo.
Una volta in salvo ho provato con tre siluri ad affondare il Kabalo.
Visto che nessuno dei tre siluri è scoppiato l'ho preso a cannonate.
Una volta in salvo ho provato con tre siluri ad affondare il Kabalo.
Visto che nessuno dei tre siluri è scoppiato l'ho preso a cannonate.
Erano le 4 di questa mattina, a 720 miglia per 268° dal faro di Punta Pardo, sull’isola di Madera.
Quale sarebbe il problema? Uno solo.
Gli uomini del Kabalo.
E’ vero, sono tutti in salvo.
Una lancia con 20 uomini e il capitano Vogels, l’abbiamo recuperata appena in tempo.
Quale sarebbe il problema? Uno solo.
Gli uomini del Kabalo.
E’ vero, sono tutti in salvo.
Una lancia con 20 uomini e il capitano Vogels, l’abbiamo recuperata appena in tempo.
Il tenente Reclerck, terzo ufficiale del Kabalo era rimasto sorpreso.
Tremava di freddo e mi ero tolto il maglione rimanendo a torso nudo.
“Indossatelo, vi scalderete”, gli avevo detto.
Aveva balbettato qualcosa, sicuramente un grazie, non so.
Tremava di freddo e mi ero tolto il maglione rimanendo a torso nudo.
“Indossatelo, vi scalderete”, gli avevo detto.
Aveva balbettato qualcosa, sicuramente un grazie, non so.
Poi avevo detto al capitano: “Purtroppo non posso prendervi a bordo”.
Poi sottovoce: “pensa di riuscire ad arrivare a Madera?”.
La sua risposta era stata: “No, sono più settecento miglia”.
Solo in quel momento ho capito che dovevo prendere una decisione.
L'unica.
Poi sottovoce: “pensa di riuscire ad arrivare a Madera?”.
La sua risposta era stata: “No, sono più settecento miglia”.
Solo in quel momento ho capito che dovevo prendere una decisione.
L'unica.
Quella di trascinare la lancia con gli uomini del Kabalo in salvo, fino a Madera.
O in una zona sicura.
Avevo cercato nel buio anche la seconda lancia, ma avevo captato un messaggio. Tutto bene.
Era stata recuperata da una nave battente bandiera panamense.
O in una zona sicura.
Avevo cercato nel buio anche la seconda lancia, ma avevo captato un messaggio. Tutto bene.
Era stata recuperata da una nave battente bandiera panamense.
E’ la notte del 17 ottobre.
Il mare è agitato, accidenti. Forte vento e piovaschi.
Un’ondata ha appena spezzato il cavo che teneva legata la lancia.
Ho dato l’ordine di tornare indietro per agganciarne un altro.
All’alba si è rotto pure quello.
Il mare è agitato, accidenti. Forte vento e piovaschi.
Un’ondata ha appena spezzato il cavo che teneva legata la lancia.
Ho dato l’ordine di tornare indietro per agganciarne un altro.
All’alba si è rotto pure quello.

Ho rischiato di perdere un uomo che è caduto in acqua.
Fortunatamente siamo riusciti a recuperarlo.
Diventa sempre più difficile con questo mare.
Il tempo sta peggiorando e il cavo non terrà a lungo.
Fortunatamente siamo riusciti a recuperarlo.
Diventa sempre più difficile con questo mare.
Il tempo sta peggiorando e il cavo non terrà a lungo.

Al tramonto i marinai sulla lancia si sono preoccupati perché ho fermato il sommergibile. Dovevo andare più veloce, quindi ho deciso di portare tutti a bordo lasciandone solo quattro a governare la lancia. A notte fonda, con il tempo in peggioramento, ho preso a bordo anche loro. 

A bordo non significa dentro il sommergibile.
Non c’è abbastanza spazio.
Si sono rannicchiati nella falsa torre.
Cosa è la falsa torre? Avete presente la zona della torretta?
Ecco, lì dentro ci sono piccoli spazi adibiti a latrine, lavandini, cucine.
Non c’è abbastanza spazio.
Si sono rannicchiati nella falsa torre.
Cosa è la falsa torre? Avete presente la zona della torretta?
Ecco, lì dentro ci sono piccoli spazi adibiti a latrine, lavandini, cucine.

Falsa torre perché non fa parte dello stagno del sommergibile e in immersione si riempie d’acqua.
Sardine in scatola, insomma, tra cordami e attrezzi.
Li sento urlare, piangere, ma non ho altro da offrire loro.
Spero solo di non dover immergere il sommergibile.
Sardine in scatola, insomma, tra cordami e attrezzi.
Li sento urlare, piangere, ma non ho altro da offrire loro.
Spero solo di non dover immergere il sommergibile.

All’alba del 19 ottobre 1940 il sommergibile Cappellini si arrestò in una insenatura dell’isola di Santa Maria delle Azzorre.
I “naufraghi” furono sbarcati quattro alla volta con il battellino del sommergibile.
Il tenente del Kabalo, Caudron, si avvicinò al comandante.
I “naufraghi” furono sbarcati quattro alla volta con il battellino del sommergibile.
Il tenente del Kabalo, Caudron, si avvicinò al comandante.

“Mi dica il suo nome per favore”.
“A che servirebbe” rispose il comandante.
“Ho quattro figli. Vorrei che nelle loro preghiere ricordassero il nome di chi salvò il loro padre”.
“Dite ai vostri figli di pregare per Salvatore Bruno”.
“A che servirebbe” rispose il comandante.
“Ho quattro figli. Vorrei che nelle loro preghiere ricordassero il nome di chi salvò il loro padre”.
“Dite ai vostri figli di pregare per Salvatore Bruno”.
Il comandante gli aveva rivelato solo i suoi nomi di battesimo, tacendo il cognome.
Lui era fatto così. Per questo era molto amato dai suoi uomini e da tutti quelli che lo conoscevano.
Chiese anche ai suoi uomini di non raccontare mai del salvataggio.
Lui era fatto così. Per questo era molto amato dai suoi uomini e da tutti quelli che lo conoscevano.
Chiese anche ai suoi uomini di non raccontare mai del salvataggio.
La storia di quel salvataggio venne alla luce 10 anni dopo, quando il tenente Caudron raccontò la storia su “La Gazette de Bruxelles”. Ed ebbe ampia risonanza in tutto il mondo.
La Marina italiana e i tedeschi sapevano già tutto.
Sapevano cosa aveva fatto il comandante Todaro.
La Marina italiana e i tedeschi sapevano già tutto.
Sapevano cosa aveva fatto il comandante Todaro.

Il comandante Salvatore Todaro aveva provveduto ad inviare un radiotelegramma al suo ammiraglio dopo il salvataggio.
“16 ottobre 1940: ho affondato il piroscafo belga Kabalo, ho sbarcato i naufraghi a Santa Maria delle Azzorre.
“16 ottobre 1940: ho affondato il piroscafo belga Kabalo, ho sbarcato i naufraghi a Santa Maria delle Azzorre.

Non l’aveva presa bene.
L’ammiraglio, intendo.
L’isola distava tre giorni di navigazione dal punto di contatto.
In pratica una settimana di attività bellica perduta. Non solo. In quella settimana il sommergibile poteva essere intercettato dal nemico.
L’ammiraglio, intendo.
L’isola distava tre giorni di navigazione dal punto di contatto.
In pratica una settimana di attività bellica perduta. Non solo. In quella settimana il sommergibile poteva essere intercettato dal nemico.
Todaro si ripeté il 5 gennaio 1941, tra le isole Canarie e la costa africana quando il Cappellini affondò, sempre con il cannone, il piroscafo armato inglese Shakespeare.
Todaro raccolse i 22 superstiti mettendoli in salvo sulle coste dell'isola di Capo Verde.
Todaro raccolse i 22 superstiti mettendoli in salvo sulle coste dell'isola di Capo Verde.
Ricordate che Todaro dormiva pochissimo? Stanco ed esausto si addormentò, purtroppo profondamente la notte del 13 dicembre 1942 nella base di La Galite in Tunisia.
Sul motopeschereccio armato Cefalo.
Colpito da un colpo di una mitraglia aerea morirà sul colpo. A soli 34 anni.
Sul motopeschereccio armato Cefalo.
Colpito da un colpo di una mitraglia aerea morirà sul colpo. A soli 34 anni.

L’ammiraglio tedesco Dönitz era stato duro con il comandante Todaro.
“Un comandante tedesco mai avrebbe anteposto la sorte dei naufraghi allo svolgimento della sua missione”.
“Un comandante tedesco non ha, come il sottoscritto, duemila anni di civiltà sulle spalle” la risposta.
“Un comandante tedesco mai avrebbe anteposto la sorte dei naufraghi allo svolgimento della sua missione”.
“Un comandante tedesco non ha, come il sottoscritto, duemila anni di civiltà sulle spalle” la risposta.

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh