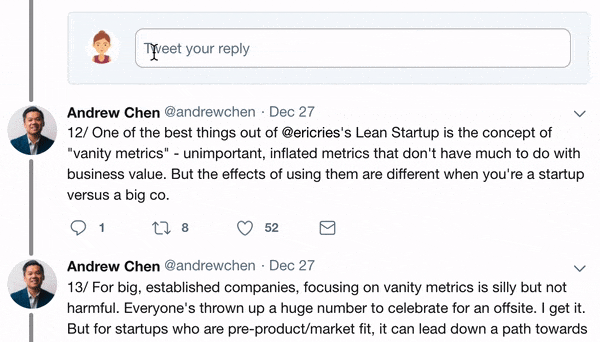Qualcuno ha scritto che “i numeri costituiscono il solo linguaggio universale”.
Vero. Anche perché i numeri non sono mai solo numeri.
100
1.000.000
Cento
Un milione.
Vero. Anche perché i numeri non sono mai solo numeri.
100
1.000.000
Cento
Un milione.
Oppure 7 come le persone che incontrai quando tornai a Kigali il 21 luglio del 1994.
2, come le esplosioni che udimmo quella sera del 6 aprile 1994 quando tutto ebbe inizio.
Subito dopo la telefonata della mia segretaria.
«Hanno abbattuto l’aereo del Presidente Habyarimana»
2, come le esplosioni che udimmo quella sera del 6 aprile 1994 quando tutto ebbe inizio.
Subito dopo la telefonata della mia segretaria.
«Hanno abbattuto l’aereo del Presidente Habyarimana»

Quella notizia significava una cosa sola. Guai.
E scontri in città.
Quella notte dormimmo tutti in bagno, l’unica stanza della casa che non poteva essere raggiunta da eventuali colpi esplosi dalla strada.
Mentre il telefono continuava a squillare.
E scontri in città.
Quella notte dormimmo tutti in bagno, l’unica stanza della casa che non poteva essere raggiunta da eventuali colpi esplosi dalla strada.
Mentre il telefono continuava a squillare.
Tutti a chiedermi cosa stesse accadendo.
Cosa fare, come comportarsi, come prepararsi al peggio. Perché si rivolgevano a me?
Perché vivevo in Ruanda da trent’anni. Non solo.
Dal 1988 ero console onorario della Repubblica Italiana a Kigali.
Cosa fare, come comportarsi, come prepararsi al peggio. Perché si rivolgevano a me?
Perché vivevo in Ruanda da trent’anni. Non solo.
Dal 1988 ero console onorario della Repubblica Italiana a Kigali.
Mi chiamo Pierantonio Costa e sono nato a Mestre, penultimo di sette fratelli, il 7 maggio 1939.
E visto che parliamo di numeri…
15, come gli anni che avevo quando raggiunsi mio padre che era emigrato per lavoro nella Repubblica Democratica del Congo.
E visto che parliamo di numeri…
15, come gli anni che avevo quando raggiunsi mio padre che era emigrato per lavoro nella Repubblica Democratica del Congo.
Le prime avvisaglie di cosa può essere una guerra in Africa, con la rivolta mulelista, e poi la fuga a Kigali, in Ruanda.
Nel 1965 il primo permesso permanente.
E il matrimonio con Mariann, una cittadina svizzera.
3, come i nostri figli. Olivier, Caroline e Matteo.
Nel 1965 il primo permesso permanente.
E il matrimonio con Mariann, una cittadina svizzera.
3, come i nostri figli. Olivier, Caroline e Matteo.
Il Ruanda, il Paese dalle mille colline.
Il 7 aprile del 1994 quello stesso Paese diventò un immenso mattatoio.
Io, Console e imprenditore.
4, come le imprese che avevo in Ruanda di import-export.
150, come il numero dei miei dipendenti.
Il 7 aprile del 1994 quello stesso Paese diventò un immenso mattatoio.
Io, Console e imprenditore.
4, come le imprese che avevo in Ruanda di import-export.
150, come il numero dei miei dipendenti.

Dopo quelle due esplosioni del 6 aprile 1994 e la telefonata della mia segretaria capii che dovevo fare qualcosa.
250, come il numero degli italiani presenti nelle liste consolari.
Fortunatamente i telefoni funzionavano.
Cercai di contattarli, sotto il rumore dei mortai.
250, come il numero degli italiani presenti nelle liste consolari.
Fortunatamente i telefoni funzionavano.
Cercai di contattarli, sotto il rumore dei mortai.
Il dramma si stava delineando e io non avevo tempo da perdere.
Ero l’unica figura istituzionale dell’Italia presente in Ruanda.
Dovevo andare in città per recuperare i miei connazionali.
Mia moglie Mariann si mise a disfare i vestiti per ricavare stoffe bianche, rosse e verdi.
Ero l’unica figura istituzionale dell’Italia presente in Ruanda.
Dovevo andare in città per recuperare i miei connazionali.
Mia moglie Mariann si mise a disfare i vestiti per ricavare stoffe bianche, rosse e verdi.
Per cucire alcune bandiere italiane.
Se volevo circolare in città mi avrebbero fatto comodo.
E in città, tra le strade deserte, vidi solo militari e gente, tanta gente col machete in mano.
Con la precisa volontà di eliminare tutti i tutsi.
Se volevo circolare in città mi avrebbero fatto comodo.
E in città, tra le strade deserte, vidi solo militari e gente, tanta gente col machete in mano.
Con la precisa volontà di eliminare tutti i tutsi.
Con le squadre della morte in azione il mio compito non era per niente facile.
Recuperare gli italiani, predisporre i blindati necessari, organizzare e far atterrare i nostri aerei per portare lontano, e in salvo, più persone possibili.
Recuperare gli italiani, predisporre i blindati necessari, organizzare e far atterrare i nostri aerei per portare lontano, e in salvo, più persone possibili.
Il tesserino consolare fu un buon lasciapassare.
Anche se a ogni blocco bisognava fermarsi, discutere per poter proseguire e soprattutto lasciare qualche soldo.
Quello sempre.
Riuscii a far passare gli italiani. Ma non solo loro.
Anche se a ogni blocco bisognava fermarsi, discutere per poter proseguire e soprattutto lasciare qualche soldo.
Quello sempre.
Riuscii a far passare gli italiani. Ma non solo loro.
A ogni passaggio la colonna aumentava.
Non solo italiani, non solo missionari e suore, ma anche ruandesi, belgi e francesi.
Ai posti di blocco sempre più discussioni.
Piano piano riuscii a far passare tutto il convoglio.
Fino all'arrivo all’aeroporto.
Non solo italiani, non solo missionari e suore, ma anche ruandesi, belgi e francesi.
Ai posti di blocco sempre più discussioni.
Piano piano riuscii a far passare tutto il convoglio.
Fino all'arrivo all’aeroporto.

Presi l’ultimo volo, dopo aver visto che tutti erano in salvo.
Mio figlio Olivier seduto a fianco mi disse: «Hai salvato la vita agli italiani, ma tutti i ruandesi che conoscevi? Amici e dipendenti? Perché non hai fatto niente per loro?».
Rimasi in silenzio.
Senza rispondere.
Mio figlio Olivier seduto a fianco mi disse: «Hai salvato la vita agli italiani, ma tutti i ruandesi che conoscevi? Amici e dipendenti? Perché non hai fatto niente per loro?».
Rimasi in silenzio.
Senza rispondere.
Mi trasferii a Bujumbura, capitale del Burundi dove abitava mio fratello Arturo. Il mio compito di console era finito. Avrei potuto passare le giornate sul lago Tanganica.
Ma avevo un tarlo nella testa.
E una convinzione.
Qualsiasi uomo normale può compiere cose straordinarie.
Ma avevo un tarlo nella testa.
E una convinzione.
Qualsiasi uomo normale può compiere cose straordinarie.
Che fine avevano fatto i 150 bambini dell’orfanotrofio di Nyanza? Chi li stava sfamando?
Presi quella decisione.
Quella di tornare in Ruanda per cercare di far arrivare in Burundi, e quindi salvare, il maggior numero di persone.
Pur sapendo di rischiare la vita.
Presi quella decisione.
Quella di tornare in Ruanda per cercare di far arrivare in Burundi, e quindi salvare, il maggior numero di persone.
Pur sapendo di rischiare la vita.
E così avevo fatto. Dai miei appunti.
23 aprile 1994.
51 le persone accompagnate alla frontiera.
4 maggio 1994, 32.
E poi 17. E poi altre ancora. Ancora. E ancora.
In totale oltre 2.000 le persone salvate, tra cui 375 bambini di un orfanotrofio della Croce Rossa.
23 aprile 1994.
51 le persone accompagnate alla frontiera.
4 maggio 1994, 32.
E poi 17. E poi altre ancora. Ancora. E ancora.
In totale oltre 2.000 le persone salvate, tra cui 375 bambini di un orfanotrofio della Croce Rossa.
Pierantonio Costa continuò a fare la spola tra il Ruanda e il vicino Burundi tra gente che spaccava teste col machete, stupri di massa e massacri.
Portando in salvo tutte le persone che riusciva a mettere sotto la protezione del Governo Italiano.
Portando in salvo tutte le persone che riusciva a mettere sotto la protezione del Governo Italiano.

Dopo quei terribili giorni Pierantonio Costa rimase a vivere in Ruanda.
La parte più difficile non fu quella imprenditoriale, ma quella di dimenticare l’orrore cui aveva assistito.
Con quella domanda sempre in testa.
“Avrei potuto fare di più?”
La parte più difficile non fu quella imprenditoriale, ma quella di dimenticare l’orrore cui aveva assistito.
Con quella domanda sempre in testa.
“Avrei potuto fare di più?”

Alla fine del genocidio Pierantonio Costa si ritrovò ad aver perso beni per oltre 3 milioni di dollari.
Quasi tutti usati per un unico scopo.
Superare posti di blocco, pagare mazzette
e salvare il maggior numero di persone.
Quasi tutti usati per un unico scopo.
Superare posti di blocco, pagare mazzette
e salvare il maggior numero di persone.
Pierantonio Costa ci ha lasciato il 1° gennaio del 2021. A 81 anni.
Oltre alla medaglia d’oro al valor civile, nel 2009 è stato onorato con un albero e un cippo nel Giardino dei Giusti di Milano.
Candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2011.
bit.ly/2Z6CUN8
Oltre alla medaglia d’oro al valor civile, nel 2009 è stato onorato con un albero e un cippo nel Giardino dei Giusti di Milano.
Candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2011.
bit.ly/2Z6CUN8
Non solo numeri.
100 1.000.000 416 7
100, i giorni.
1.000.000 come il numero di tutsi e hutu moderati uccisi in poco più di tre mesi, dal 7 aprile al 15 luglio 1994 in Ruanda.
416 all’ora
7 al minuto.
100 1.000.000 416 7
100, i giorni.
1.000.000 come il numero di tutsi e hutu moderati uccisi in poco più di tre mesi, dal 7 aprile al 15 luglio 1994 in Ruanda.
416 all’ora
7 al minuto.

Il genocidio del Ruanda non fu una cosa improvvisa.
Fu una follia annunciata.
Nei tre anni precedenti il Ruanda era diventato il terzo importatore d’armi di tutta l’Africa.
Centinaia di migliaia i machete arrivati dalla Cina.

Fu una follia annunciata.
Nei tre anni precedenti il Ruanda era diventato il terzo importatore d’armi di tutta l’Africa.
Centinaia di migliaia i machete arrivati dalla Cina.


E questa è la storia di Pierantonio Costa.
Che seppe instillare “Una goccia di bene nell’immenso mattatoio che fu il Ruanda di quei giorni”.
”Ho solo risposto alla mia coscienza. Quello che va fatto lo si deve fare. Sempre”.

Che seppe instillare “Una goccia di bene nell’immenso mattatoio che fu il Ruanda di quei giorni”.
”Ho solo risposto alla mia coscienza. Quello che va fatto lo si deve fare. Sempre”.


• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh