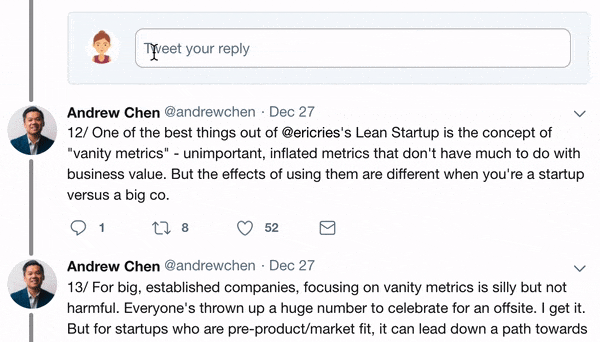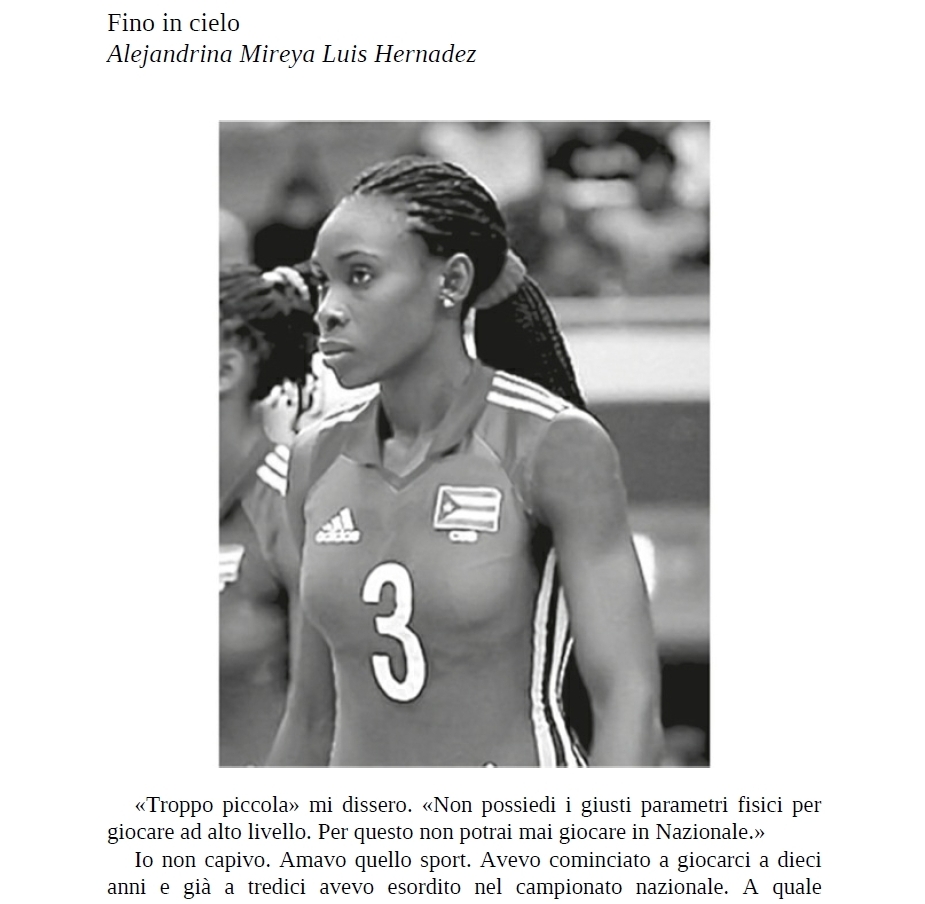23 agosto 2021.
Quarantatrè anni. Quelli che avrei potuto compiere oggi. Purtroppo è andata diversamente. So che non mi avete dimenticato. Il fatto che Johannes voglia riproporre la mia storia lo dimostra.
Una storia che inizia da una fine.
La mia ultima partita.
Quarantatrè anni. Quelli che avrei potuto compiere oggi. Purtroppo è andata diversamente. So che non mi avete dimenticato. Il fatto che Johannes voglia riproporre la mia storia lo dimostra.
Una storia che inizia da una fine.
La mia ultima partita.
Prima o poi doveva succedere.
È stato un percorso lungo, ma ho preso la mia decisione. E mentre aspetto di scendere in campo per l’ultima volta la mia mente corre a quando tutto è iniziato.
A quel “soldo di cacio” che crebbe mangiando gnocchi, lasagne e salsicce.
È stato un percorso lungo, ma ho preso la mia decisione. E mentre aspetto di scendere in campo per l’ultima volta la mia mente corre a quando tutto è iniziato.
A quel “soldo di cacio” che crebbe mangiando gnocchi, lasagne e salsicce.

Mio padre Joe lo chiamavano “Jellybean”, caramella di gelatina, perché lui era sempre sorridente e scherzava di continuo, in campo e fuori.
Voleva trasmettere la sua allegria a chi gli stava intorno.
«Alcune volte clown, altre volte giocatore di basket» scrivevano i giornali.
Voleva trasmettere la sua allegria a chi gli stava intorno.
«Alcune volte clown, altre volte giocatore di basket» scrivevano i giornali.
Mai veramente apprezzato, lasciò gli USA per approdare in Italia. Precisamente a Rieti, nella Sebastiani. Abitavamo in via Pierluigi Mariani al numero 33, ed è lì che cominciai a tirare la palla nel bidone della spazzatura all’angolo della villetta. E poi gli inizi nel minibasket
Nel 1985 giocai il Torneo Plasmon riservato ai nati nel 1975.
Un’eccezione, tanto io ero “il piccolino”.
Pronti, via. 10-0. E tutti a piangere.
Tutti, avversari e compagni. E dagli spalti le urla: «Cacciatelo via, ha stufato, fate giocare tutti! Così non si diverte nessuno!».
Un’eccezione, tanto io ero “il piccolino”.
Pronti, via. 10-0. E tutti a piangere.
Tutti, avversari e compagni. E dagli spalti le urla: «Cacciatelo via, ha stufato, fate giocare tutti! Così non si diverte nessuno!».

Già, perché io la palla non la passavo mai.
Palla, tiro, canestro. Palla, tiro, canestro.
Mi sostituirono e invece di andare a sedermi in panchina, corsi da mamma Pamela sugli spalti a piangere. Ero furioso. Sei anni e già un bel caratterino. Dan Gay veniva spesso a trovarci.
Palla, tiro, canestro. Palla, tiro, canestro.
Mi sostituirono e invece di andare a sedermi in panchina, corsi da mamma Pamela sugli spalti a piangere. Ero furioso. Sei anni e già un bel caratterino. Dan Gay veniva spesso a trovarci.

Giocava nella stessa squadra di papà, e io di frequente andavo in palestra a vedere i suoi allenamenti.
A volte lo sfidavo. Era alto 207 centimetri e pesava 109 chili.
Ora lo posso dire: è stato l’unico giocatore al mondo ad avermi sempre schiacciato in testa.
A volte lo sfidavo. Era alto 207 centimetri e pesava 109 chili.
Ora lo posso dire: è stato l’unico giocatore al mondo ad avermi sempre schiacciato in testa.
Diciamo però che avevo un’attenuante, visto che all’epoca avevo solo sei anni. Infatti, sono nato il 23 agosto del 1978. Invece oggi è il 16 aprile del 2016. Tra poco lascerò questo sport, il basket, che mi ha dato tutto e che tanto ho amato. A 37 anni, dopo 1.346 gare disputate.
Ho nostalgia dell’Italia. Un Paese che mi ha accolto con tanto amore. Dan lo diceva sempre. Vivere senza tutte quelle risse per problemi razziali come negli Stati Uniti era qualcosa di bello, di diverso. In Italia certi valori avevano un senso profondo. E poi il mangiare, ragazzi
A mamma Pamela non piaceva cucinare, così aveva scoperto quella rosticceria.
Gnocchi, pollo al forno, lasagne, patate, pizza, patatine, salsicce, per la gioia mia e delle mie sorelline. Avevo otto anni quando papà Joe andò a giocare nella Viola di Reggio Calabria.
Gnocchi, pollo al forno, lasagne, patate, pizza, patatine, salsicce, per la gioia mia e delle mie sorelline. Avevo otto anni quando papà Joe andò a giocare nella Viola di Reggio Calabria.
Per noi ragazzini, era la palestra del liceo scientifico Leonardo da Vinci il nostro campo di gioco.
Eravamo molto amici. Andavamo tutti d’accordo. Almeno fino all’inizio delle partite.
Da quel momento in poi, la volevo tutta per me.
La palla, intendo.
Eravamo molto amici. Andavamo tutti d’accordo. Almeno fino all’inizio delle partite.
Da quel momento in poi, la volevo tutta per me.
La palla, intendo.

Ero bravo, malgrado quel “piccolo” difetto.
Una volta presa la palla, i miei compagni se la potevano scordare.
Al limite potevano difendere, quello sì, visto che a me non piaceva quel fondamentale.
Papà Joe lo considerava addirittura una perdita di tempo.
Una volta presa la palla, i miei compagni se la potevano scordare.
Al limite potevano difendere, quello sì, visto che a me non piaceva quel fondamentale.
Papà Joe lo considerava addirittura una perdita di tempo.
Poi ci fu il trasferimento di papà a Pistoia. E dopo ancora a Reggio Emilia. Fu allora che capii che il basket sarebbe stato la mia vita. Il mio traguardo? Giocare nella NBA. Anche se gli Stati Uniti erano lontani, un giorno ci sarei andato. Ne ero certo. Per diventare una stella 

Lasciare l’Italia mi costò molto.
Mi sentivo italiano, cresciuto a lasagne e cappelletti e con il Milan nel cuore.
Gli amici, i compagni di squadra, quelli di scuola, e la mia amica Giorgia. Direi, più che un’amica.
Una breve parentesi in Francia e poi a Philadelphia.
Mi sentivo italiano, cresciuto a lasagne e cappelletti e con il Milan nel cuore.
Gli amici, i compagni di squadra, quelli di scuola, e la mia amica Giorgia. Direi, più che un’amica.
Una breve parentesi in Francia e poi a Philadelphia.
Non parlavo bene l’inglese, mi sentivo un pesce fuor d’acqua.
Quello che accadde dopo ormai lo sapete.
Prima alla Lower Merion High School, con il record di punti, poi direttamente tra i professionisti nei Los Angeles Lakers, senza passare dall’università.

Quello che accadde dopo ormai lo sapete.
Prima alla Lower Merion High School, con il record di punti, poi direttamente tra i professionisti nei Los Angeles Lakers, senza passare dall’università.


Avevo 18 anni e 72 giorni, il giorno del mio esordio.
Un record. Vent’anni giocati ad alto livello con 5 titoli NBA e due medaglie d’oro olimpiche, passando tra infortuni che avrebbero steso chiunque.
Fu un giorno fantastico quando superai nei punti il mio idolo Michael Jordan.
Un record. Vent’anni giocati ad alto livello con 5 titoli NBA e due medaglie d’oro olimpiche, passando tra infortuni che avrebbero steso chiunque.
Fu un giorno fantastico quando superai nei punti il mio idolo Michael Jordan.
Era il 14 dicembre 2014. Quella volta misi a segno il punto numero 32.293. Terzo marcatore di sempre.
Ma la mia felicità non era dovuta a quel numero, bensì al fatto che in tribuna c’era la mia famiglia, mia moglie Vanessa e le nostre bambine.
Devo molto all’Italia.
Ma la mia felicità non era dovuta a quel numero, bensì al fatto che in tribuna c’era la mia famiglia, mia moglie Vanessa e le nostre bambine.
Devo molto all’Italia.
Non sarei mai stato quello che sono senza quegli anni trascorsi da voi.
Fin dal primo giorno, quando qualcuno mi chiese quale fosse il mio nome.
Risposi: «My name is Kobe, Kobe Bryant».
Oggi lo posso dire nella vostra lingua.
Il mio nome è Kobe, Kobe Bryant.
Fin dal primo giorno, quando qualcuno mi chiese quale fosse il mio nome.
Risposi: «My name is Kobe, Kobe Bryant».
Oggi lo posso dire nella vostra lingua.
Il mio nome è Kobe, Kobe Bryant.

Ora devo andare. Sento già la gente che urla a gran voce il mio nome.Oggi, 16 aprile 2016, giocherò l’ultima partita e poi lascerò il basket. Perché «Cara pallacanestro…il mio cuore può reggere il peso, anche la mia mente, ma il mio corpo sa che è giunto il momento di salutarci»
Il 16 aprile 2016, Kobe Bryant giocò la sua ultima partita contro gli Utah Jazz.
Inizialmente una partita anonima, come accade sempre in queto tipo di aprtite.
Poi, improvvisamente, il “soldo di cacio” prese il sopravvento. Kobe Bryant tornò quel bambino che non la passava mai.
Inizialmente una partita anonima, come accade sempre in queto tipo di aprtite.
Poi, improvvisamente, il “soldo di cacio” prese il sopravvento. Kobe Bryant tornò quel bambino che non la passava mai.
Palla, tiro, canestro. Palla, tiro, canestro, trascinò la sua squadra fino all’ennesima vittoria.
Il record precedente di punti in una partita d’addio?
27, appartenente al mitico John “Hondo” Havlicek.
Quel giorno Kobe Bryant di punti ne realizzò 60, tirando cinquanta volte.
Il record precedente di punti in una partita d’addio?
27, appartenente al mitico John “Hondo” Havlicek.
Quel giorno Kobe Bryant di punti ne realizzò 60, tirando cinquanta volte.

Nessuno negli ultimi trent’anni aveva mai tirato così tanto.
Kobe Bryant diede in questo modo l’addio al basket, dopo vent’anni giocati sempre nella stessa squadra, i Los Angeles Lakers, che in seguito ritirarono i suoi numeri, l’8 e il 24.
Kobe Bryant diede in questo modo l’addio al basket, dopo vent’anni giocati sempre nella stessa squadra, i Los Angeles Lakers, che in seguito ritirarono i suoi numeri, l’8 e il 24.

Bryant aveva annunciato il ritiro con una lettera, che successivamente ha ispirato un cortometraggio di Glen Kean, premio Oscar nel 2018, Dear Basketball.
Una lettera indirizzata alla pallacanestro.
Una lettera d’amore che vale per tutti gli sport.
bit.ly/3sGFUhp
Una lettera indirizzata alla pallacanestro.
Una lettera d’amore che vale per tutti gli sport.
bit.ly/3sGFUhp
Il 26 gennaio 2020, l’elicottero su cui viaggiavano Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre sette persone è precipitato presso le colline di Calabasas. 

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh